Buonasera, È la prima volta che scrivo online, ma credo che possiate aiutarmi a darmi un parere. È
25
risposte
Buonasera,
È la prima volta che scrivo online, ma credo che possiate aiutarmi a darmi un parere. È da quasi sei anni che ho iniziato un percorso di psicoanalisi per depressione legata a traumi e famiglia disfunzionale in generale. Non ho mai avuto un ottimo rapporto con la mia psicoanalista, ma poi, analizzandomi, ho realizzato che si era attivato un transfert negativo in cui ho trasferito su di lei il rapporto che ho con mia madre. Tuttavia, durante l'ultima seduta che è stata martedì mattina, mentre le parlavo dei miei problemi lei a un certo punto mi ha detto che doveva alzarsi e camminare un po' in quanto aveva un dolore agli occhi che le passava solo quando camminava, fin qui tutto bene se non che all'improvviso, mentre io stavo parlando (seppur con voce alta) lei si è messa ad urlare in un modo spropositato mentre continuava a camminare tanto che a un certo punto si è avvicinata alla mia sedia e continuava ad urlarmi addosso criticando il mio atteggiamento verso i miei genitori mentre era in piedi vicino a me tanto che non mi sono sentita più al sicuro e ho temuto che potesse anche alzare le mani, per cui ho deciso di interrompere la seduta prima del previsto e quando me ne stavo andando via lei ha anche provato a dirmi che non potevo andarmene e che avrebbe smesso di urlare ma io mi sono veramente spaventata e me ne sono andata via e sto iniziando a pensare anche di interrompere prematuramente il percorso e di fare quindi drop out. Gliel'ho gia iniziato a dire per messaggio su whats app che non intendo più continuare ma lei ha detto che la sua reazione è stata frutto del contro transfert ed è stato un suo modo per provare a scuotermi dal torpore anche se lei sa bene che le urla mi scaturiscono l'effetto contrario in quanto mio padre spesso è solito urlare per cui quando una persona urla, lei sa bene che io mi blocco. Tuttavia, non so se sia frutto della mia esagerazione e sia veramente il caso di fare drop out o se provare a continuare con lei.. in ogni caso, per sicurezza ho già chiesto alla mia nutrizionista se può aiutarmi a cercare altri terapeuti.. devo anche sottolineare che non sono una paziente facile, in quanto sono molto diffidente di mia natura e spesso faccio perdere la pazienza e inoltre sono in attesa di un intervento di artrodesi vertebrale che mi sta provocando uno stato di iper vigilanza generale.. ma quello che mi chiedo è, in questo caso è utile continuare con lei o è meglio cambiare? Perché adesso ho un blocco nei suoi confronti però al tempo stesso mi sento in colpa verso di lei per aver interrotto così improvvisamente la terapia ..
È la prima volta che scrivo online, ma credo che possiate aiutarmi a darmi un parere. È da quasi sei anni che ho iniziato un percorso di psicoanalisi per depressione legata a traumi e famiglia disfunzionale in generale. Non ho mai avuto un ottimo rapporto con la mia psicoanalista, ma poi, analizzandomi, ho realizzato che si era attivato un transfert negativo in cui ho trasferito su di lei il rapporto che ho con mia madre. Tuttavia, durante l'ultima seduta che è stata martedì mattina, mentre le parlavo dei miei problemi lei a un certo punto mi ha detto che doveva alzarsi e camminare un po' in quanto aveva un dolore agli occhi che le passava solo quando camminava, fin qui tutto bene se non che all'improvviso, mentre io stavo parlando (seppur con voce alta) lei si è messa ad urlare in un modo spropositato mentre continuava a camminare tanto che a un certo punto si è avvicinata alla mia sedia e continuava ad urlarmi addosso criticando il mio atteggiamento verso i miei genitori mentre era in piedi vicino a me tanto che non mi sono sentita più al sicuro e ho temuto che potesse anche alzare le mani, per cui ho deciso di interrompere la seduta prima del previsto e quando me ne stavo andando via lei ha anche provato a dirmi che non potevo andarmene e che avrebbe smesso di urlare ma io mi sono veramente spaventata e me ne sono andata via e sto iniziando a pensare anche di interrompere prematuramente il percorso e di fare quindi drop out. Gliel'ho gia iniziato a dire per messaggio su whats app che non intendo più continuare ma lei ha detto che la sua reazione è stata frutto del contro transfert ed è stato un suo modo per provare a scuotermi dal torpore anche se lei sa bene che le urla mi scaturiscono l'effetto contrario in quanto mio padre spesso è solito urlare per cui quando una persona urla, lei sa bene che io mi blocco. Tuttavia, non so se sia frutto della mia esagerazione e sia veramente il caso di fare drop out o se provare a continuare con lei.. in ogni caso, per sicurezza ho già chiesto alla mia nutrizionista se può aiutarmi a cercare altri terapeuti.. devo anche sottolineare che non sono una paziente facile, in quanto sono molto diffidente di mia natura e spesso faccio perdere la pazienza e inoltre sono in attesa di un intervento di artrodesi vertebrale che mi sta provocando uno stato di iper vigilanza generale.. ma quello che mi chiedo è, in questo caso è utile continuare con lei o è meglio cambiare? Perché adesso ho un blocco nei suoi confronti però al tempo stesso mi sento in colpa verso di lei per aver interrotto così improvvisamente la terapia ..
Buonasera ammetto di non essere di un orientamento psicoanalitico bensì cognitivo comportamentale ma caspita credo che queste cose in terapia non debbano accadere. Non si dovrebbe avere paura della propria terapeuta. Mi dispiace molto per quello che le è accaduto
Risolvi i tuoi dubbi grazie alla consulenza online
Se hai bisogno del consiglio di uno specialista, prenota una consulenza online. Otterrai risposte senza muoverti da casa.
Mostra risultati Come funziona?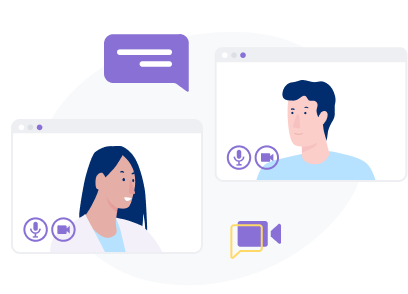

Buonasera,
Grazie per la sua domanda.
Dal suo racconto emerge una situazione delicata: la relazione con la collega, sebbene lunga, non è da lei considerata adeguata anche a causa del transfert nei suoi confronti. Tuttavia, il transfert le ha fatto comprendere le dinamiche del suo rapporto con sua madre, elemento positivo. Pertanto, è stato utile.
Per quanto riguarda la sua domanda, non esiste una risposta giusta o sbagliata: è bene fare ciò che la fa sentire meglio e le dà maggiore serenità.
Una possibilità è rappresentata dal parlare in seduta con la sua terapeuta di quello che è successo per capire come potete venirne fuori insieme. Potrebbe essere un modo per ripartire, o, eventualmente, per chiudere il percorso avendo fatto chiarezza.
La invito a riflettere su quanto per lei è importante proseguire questo percorso o concluderlo aprendone uno nuovo. Cosa la fa stare meglio? Di cosa avrebbe bisogno adesso? Provi a pensare a questi aspetti prima di prendere una decisione. Ciò che conta realmente è il suo benessere: lo metta sempre al primo posto.
Resto a disposizione per ulteriori informazioni e domande. Cordiali saluti.
Grazie per la sua domanda.
Dal suo racconto emerge una situazione delicata: la relazione con la collega, sebbene lunga, non è da lei considerata adeguata anche a causa del transfert nei suoi confronti. Tuttavia, il transfert le ha fatto comprendere le dinamiche del suo rapporto con sua madre, elemento positivo. Pertanto, è stato utile.
Per quanto riguarda la sua domanda, non esiste una risposta giusta o sbagliata: è bene fare ciò che la fa sentire meglio e le dà maggiore serenità.
Una possibilità è rappresentata dal parlare in seduta con la sua terapeuta di quello che è successo per capire come potete venirne fuori insieme. Potrebbe essere un modo per ripartire, o, eventualmente, per chiudere il percorso avendo fatto chiarezza.
La invito a riflettere su quanto per lei è importante proseguire questo percorso o concluderlo aprendone uno nuovo. Cosa la fa stare meglio? Di cosa avrebbe bisogno adesso? Provi a pensare a questi aspetti prima di prendere una decisione. Ciò che conta realmente è il suo benessere: lo metta sempre al primo posto.
Resto a disposizione per ulteriori informazioni e domande. Cordiali saluti.
Gentile utente,
leggendo il suo racconto si avverte chiaramente lo stato di shock e di profondo smarrimento che sta attraversando. Quello che lei descrive non è un dettaglio tecnico della terapia, ma una ferita inferta allo spazio sacro dell'incontro tra due persone: la sicurezza.
Nella prospettiva umanistica, la stanza della terapia deve essere un "grembo" simbolico, un luogo di accoglienza incondizionata dove il paziente può finalmente abbassare le difese. Quando un terapeuta urla addosso a un paziente, specialmente a chi ha già vissuto l'urlo come trauma nel contesto familiare, non sta attuando una tecnica, ma sta rompendo l'alleanza terapeutica. Il senso di minaccia fisica che ha percepito è un segnale del suo corpo che non va ignorato; il corpo ha una sua saggezza e, in questo caso, le ha comunicato che quel luogo non era più sicuro per lei.
Giustificare un'esplosione di rabbia come "frutto del controtransfert" per "scuotere dal torpore" è una spiegazione che rischia di minimizzare il suo vissuto. Il controtransfert è uno strumento che il terapeuta deve saper gestire internamente o in supervisione; non può diventare una licenza per agire dinamiche che ricalcano proprio i traumi (l'urlo del padre) da cui lei sta cercando di guarire.
Non si senta "una paziente difficile". La diffidenza è spesso il modo in cui una persona che ha sofferto protegge la propria parte più fragile; non è una colpa, ma una richiesta di estrema delicatezza. Il senso di colpa che prova ora verso la dottoressa è comprensibile, ma è probabilmente un riflesso di quei "patti di lealtà" infantili che portano a sentirsi responsabili delle reazioni degli adulti, anche quando queste sono inappropriate.
In un percorso che dura da sei anni, il dubbio di un cambiamento è doloroso, ma a volte quello che chiamiamo "drop-out" è in realtà un atto di auto-conservazione e di profondo rispetto verso se stessi. La terapia serve a ridarle sovranità sulla sua vita, non a sottoporla a nuovi stati di iper-vigilanza, specialmente in un momento in cui la sua salute fisica, con l'intervento che la attende, richiede protezione e accudimento.
Si ascolti con verità: la cura non può mai passare attraverso la paura.
Un caro saluto,
Dott.ssa Maria Pandolfo
Psicologa Clinica e della Riabilitazione ad indirizzo Umanista
Ricevo anche online
leggendo il suo racconto si avverte chiaramente lo stato di shock e di profondo smarrimento che sta attraversando. Quello che lei descrive non è un dettaglio tecnico della terapia, ma una ferita inferta allo spazio sacro dell'incontro tra due persone: la sicurezza.
Nella prospettiva umanistica, la stanza della terapia deve essere un "grembo" simbolico, un luogo di accoglienza incondizionata dove il paziente può finalmente abbassare le difese. Quando un terapeuta urla addosso a un paziente, specialmente a chi ha già vissuto l'urlo come trauma nel contesto familiare, non sta attuando una tecnica, ma sta rompendo l'alleanza terapeutica. Il senso di minaccia fisica che ha percepito è un segnale del suo corpo che non va ignorato; il corpo ha una sua saggezza e, in questo caso, le ha comunicato che quel luogo non era più sicuro per lei.
Giustificare un'esplosione di rabbia come "frutto del controtransfert" per "scuotere dal torpore" è una spiegazione che rischia di minimizzare il suo vissuto. Il controtransfert è uno strumento che il terapeuta deve saper gestire internamente o in supervisione; non può diventare una licenza per agire dinamiche che ricalcano proprio i traumi (l'urlo del padre) da cui lei sta cercando di guarire.
Non si senta "una paziente difficile". La diffidenza è spesso il modo in cui una persona che ha sofferto protegge la propria parte più fragile; non è una colpa, ma una richiesta di estrema delicatezza. Il senso di colpa che prova ora verso la dottoressa è comprensibile, ma è probabilmente un riflesso di quei "patti di lealtà" infantili che portano a sentirsi responsabili delle reazioni degli adulti, anche quando queste sono inappropriate.
In un percorso che dura da sei anni, il dubbio di un cambiamento è doloroso, ma a volte quello che chiamiamo "drop-out" è in realtà un atto di auto-conservazione e di profondo rispetto verso se stessi. La terapia serve a ridarle sovranità sulla sua vita, non a sottoporla a nuovi stati di iper-vigilanza, specialmente in un momento in cui la sua salute fisica, con l'intervento che la attende, richiede protezione e accudimento.
Si ascolti con verità: la cura non può mai passare attraverso la paura.
Un caro saluto,
Dott.ssa Maria Pandolfo
Psicologa Clinica e della Riabilitazione ad indirizzo Umanista
Ricevo anche online
Buonasera, da ciò che racconta emerge una situazione emotivamente molto intensa e comprensibilmente destabilizzante. Quando si intraprende un percorso terapeutico, soprattutto se affronta temi profondi legati a traumi e relazioni familiari complesse, si crea uno spazio che dovrebbe essere percepito come sufficientemente sicuro, nel quale poter esprimere vulnerabilità senza timore di sentirsi sopraffatti. Il fatto che durante l’ultima seduta lei abbia provato paura e abbia sentito di non essere più al sicuro è un elemento molto importante e merita di essere preso sul serio, senza sminuirlo o metterlo in secondo piano. È molto significativo che lei sia riuscita a riflettere su ciò che può essere successo a livello relazionale, riconoscendo anche la possibilità che alcune dinamiche del passato possano riattivarsi nel rapporto terapeutico. Questo dimostra una buona capacità di osservazione su di sé e sui propri vissuti. Allo stesso tempo, però, è fondamentale distinguere tra ciò che appartiene alla storia personale e ciò che riguarda il modo in cui ci si sente nel presente dentro la relazione terapeutica. Il fatto che lei abbia percepito urla, vicinanza fisica e un clima che ha attivato paura e blocco emotivo rappresenta un’esperienza che, indipendentemente dalle spiegazioni che possono essere state date, ha avuto un impatto reale su di lei. In un percorso psicologico la fiducia e il senso di sicurezza costituiscono una base essenziale per poter lavorare sui propri vissuti. Quando questi elementi vengono meno, può emergere un blocco emotivo che rende molto difficile aprirsi e sentirsi liberi di esplorare le proprie fragilità. Il senso di colpa che lei descrive è una reazione molto frequente in persone che hanno imparato, nel corso della propria storia, a dare molto spazio ai bisogni e alle aspettative degli altri, rischiando di mettere in secondo piano i propri vissuti e il proprio benessere. Il fatto che lei si definisca una paziente diffidente o difficile potrebbe rappresentare una modalità con cui prova a spiegarsi alcune difficoltà relazionali, ma è importante considerare che la diffidenza spesso nasce come forma di protezione, soprattutto quando si sono vissute esperienze in cui la fiducia è stata messa a dura prova. Portare questa parte di sé in terapia non è un ostacolo, ma può essere un materiale prezioso di lavoro, purché avvenga all’interno di una relazione percepita come sufficientemente stabile e rispettosa dei propri tempi emotivi. Un altro elemento che merita attenzione riguarda la fase delicata che sta attraversando, segnata anche dall’attesa di un intervento chirurgico e da uno stato di allerta generale. In momenti di maggiore vulnerabilità emotiva, le reazioni intense all’interno di una relazione significativa, come quella terapeutica, possono avere un impatto ancora più forte e generare confusione su cosa sia più giusto fare. La domanda che lei si pone su come procedere è molto comprensibile. In queste situazioni può essere utile provare a osservare quali emozioni emergono quando immagina di continuare il percorso con la stessa terapeuta e quali invece emergono quando pensa a un cambiamento. Non si tratta tanto di stabilire quale scelta sia giusta in assoluto, ma quale possa permetterle di sentirsi più al sicuro e nelle condizioni di lavorare davvero su ciò che la fa soffrire. Talvolta affrontare apertamente ciò che è accaduto, se ci si sente nelle condizioni di farlo, può offrire uno spazio per chiarire e comprendere meglio la relazione terapeutica. Altre volte, invece, la sensazione di rottura può essere tale da rendere più utile valutare un nuovo percorso con un altro professionista. Entrambe le possibilità possono essere legittime e non rappresentano necessariamente un fallimento o un abbandono, ma una scelta orientata alla tutela del proprio benessere psicologico. È importante anche considerare che interrompere un percorso dopo molti anni può generare vissuti di perdita, senso di colpa o paura di ricominciare. Queste emozioni sono comprensibili e fanno parte del processo di cambiamento. Cercare informazioni su altri professionisti, come lei ha già iniziato a fare, può rappresentare un modo per prendersi cura di sé e per valutare con maggiore serenità quale direzione intraprendere. Il fatto che lei stia riflettendo con attenzione su ciò che prova, invece di prendere una decisione impulsiva, è un segnale di grande consapevolezza e rispetto verso se stessa. Darsi il permesso di considerare i propri bisogni di sicurezza emotiva come validi e importanti può rappresentare un passaggio molto significativo nel suo percorso personale. Resto a disposizione. Dott. Andrea Boggero
Buongiorno. La decisione se continuare il percorso in essere o intraprenderne uno nuovo spetta solamente a lei. Può esserle utile sapere che uno dei predittori principali del buon esito di una terapia sia la qualità della relazione che si forma con il terapeuta, prima ancora del tipo di approccio alla psicoterapia utilizzato dal terapeuta stesso.
Gentile, immagino che quanto accaduto l'abbia scossa. Credo utile e necessario un incontro con la sua psicologa per parlare di quanto lei ha vissuto: se ha un blocco nei confronti della terapeuta ma allo stesso tempo si sente in colpa, confrontarsi con lei autenticamente, esprimendo tutto ciò che sente, potrà aiutarla a decidere se proseguire o meno la terapia. La chiusura di un percorso è un momento importante in cui si tirano le fila del cambiamento e dei benefici ottenuti ma anche un momento significativo di chiusura della relazione d'aiuto. Un caro saluto.

Buongiorno, grazie per la spiegazione accurata della situazione. Prima di tutto la inviterei a valutare i 6 anni trascorsi in terapia, i progressi fatti e l'andamento della relazione con la terapeuta, al fine di comprendere se è soddisfatta della terapia fatta e della relazione. Infatti 6 anni di lavoro non sono pochi e consentono di farsi un'idea in senso ampio sul proprio percorso. Se l'evento che descrive fosse accaduto dopo pochi mesi dall'inizio della terapia, le avrei consigliato di provare a proseguire ancora un pò, e darsi del tempo per valutare. Tuttavia, considerato tutto, può anche essere che un cambiamento di approccio terapeutico le possa essere utile, al di là della relazione con la terapeuta. In ultimo vorrei rassicurarla rispetto al fatto che dice di "non essere una paziente facile". Non è il paziente che ha il dovere di semplificare la terapia, ma fa quello che può con le risorse che ha nel dato momento di sofferenza. Quindi è importante che si ricordi che va i terapia per lei, non per compiacere la terapeuta, e che non ha colpe nel prendere decisioni che riguardano il suo benessere. Se dovesse avere altre domande, non esiti a contattarmi in chat. Dott.ssa Anna Tosi

Gentile Utente,
quello che racconta è molto delicato e capisco bene quanto possa averla scossa. Ha fatto bene a fermarsi e a chiedersi che cosa sia successo, perché sentirsi al sicuro nello spazio terapeutico è una condizione fondamentale, soprattutto per chi ha una storia di traumi e di ipervigilanza come la sua.
Provo a restituirle alcuni punti, senza dare giudizi né “sentenze”.
Da un lato, è vero che in un percorso psicoanalitico possono emergere transfert e controtransfert intensi, e che talvolta il terapeuta può sentirsi emotivamente coinvolto. Tuttavia, la gestione di questi vissuti è una responsabilità del terapeuta, non del paziente. Anche quando l’intento dichiarato è “scuotere”, il modo in cui questo avviene è cruciale. Urlare, avvicinarsi fisicamente mentre l’altro è seduto, impedire di andarsene quando si sente spaventata, sono elementi che possono facilmente riattivare esperienze traumatiche pregresse, soprattutto se lei ha già condiviso che le urla la bloccano.
Ciò che colpisce, come punto centrale, più che stabilire se lei stia “esagerando” o meno, è un altro: lei si è sentita in pericolo e non al sicuro. Questo vissuto, in terapia, va preso molto seriamente. Non perché l’analista “abbia torto” in assoluto, ma perché quando la fiducia di base si incrina, il lavoro terapeutico rischia di diventare più dannoso che utile.
Inoltre è altrettanto importante ciò che dice su di sé, il sentirsi una “paziente difficile”, il senso di colpa per aver interrotto, la paura di far perdere la pazienza all’altro. Questi elementi fanno pensare che una parte di lei tenda a caricarsi di una responsabilità eccessiva anche qui, mettendo in secondo piano i propri limiti e bisogni. Il senso di colpa che prova ora potrebbe non essere solo legato alla terapeuta, ma a dinamiche più profonde e già conosciute nella sua storia relazionale.
Il fatto che oggi senta un blocco nei suoi confronti è un dato importante. A volte questo blocco può essere esplorato e lavorato insieme, altre volte, soprattutto dopo un episodio vissuto come traumatico, può essere un segnale che qualcosa si è rotto e che continuare richiederebbe uno sforzo emotivo troppo grande. Non esiste una risposta giusta uguale per tutti.
Il suo aver già iniziato a informarsi su altri professionisti non significa tradire o svalutare il lavoro fatto finora, ma prendersi cura di sé in un momento di particolare vulnerabilità, anche considerando l’intervento chirurgico imminente e lo stato di iperallerta che descrive.
Forse, più che decidere subito se “continuare o cambiare”, potrebbe essere utile chiedersi: “mi sentirei in grado di tornare da lei e parlarle di ciò che ho provato senza sentirmi di nuovo in pericolo? Oppure, in questo momento, avrei bisogno di uno spazio nuovo, più contenitivo, che mi aiuti a ristabilire una base di sicurezza?”.
Qualunque scelta farà, interrompere una terapia non la rende ingrata, sbagliata o irresponsabile. I percorsi possono anche concludersi quando non sono più sostenibili, e questo non cancella il lavoro fatto né il valore dell’impegno che lei ha messo in questi anni.
Si conceda il diritto di ascoltarsi, senza forzarsi per senso di colpa. La terapia dovrebbe essere un luogo in cui, pur nel confronto e nella fatica, ci si sente protetti.
Resto a disposizione per ulteriori approfondimenti.
Un caro saluto, dott.ssa Martina Veracini
Provo a restituirle alcuni punti, senza dare giudizi né “sentenze”.
Da un lato, è vero che in un percorso psicoanalitico possono emergere transfert e controtransfert intensi, e che talvolta il terapeuta può sentirsi emotivamente coinvolto. Tuttavia, la gestione di questi vissuti è una responsabilità del terapeuta, non del paziente. Anche quando l’intento dichiarato è “scuotere”, il modo in cui questo avviene è cruciale. Urlare, avvicinarsi fisicamente mentre l’altro è seduto, impedire di andarsene quando si sente spaventata, sono elementi che possono facilmente riattivare esperienze traumatiche pregresse, soprattutto se lei ha già condiviso che le urla la bloccano.
Ciò che colpisce, come punto centrale, più che stabilire se lei stia “esagerando” o meno, è un altro: lei si è sentita in pericolo e non al sicuro. Questo vissuto, in terapia, va preso molto seriamente. Non perché l’analista “abbia torto” in assoluto, ma perché quando la fiducia di base si incrina, il lavoro terapeutico rischia di diventare più dannoso che utile.
Inoltre è altrettanto importante ciò che dice su di sé, il sentirsi una “paziente difficile”, il senso di colpa per aver interrotto, la paura di far perdere la pazienza all’altro. Questi elementi fanno pensare che una parte di lei tenda a caricarsi di una responsabilità eccessiva anche qui, mettendo in secondo piano i propri limiti e bisogni. Il senso di colpa che prova ora potrebbe non essere solo legato alla terapeuta, ma a dinamiche più profonde e già conosciute nella sua storia relazionale.
Il fatto che oggi senta un blocco nei suoi confronti è un dato importante. A volte questo blocco può essere esplorato e lavorato insieme, altre volte, soprattutto dopo un episodio vissuto come traumatico, può essere un segnale che qualcosa si è rotto e che continuare richiederebbe uno sforzo emotivo troppo grande. Non esiste una risposta giusta uguale per tutti.
Il suo aver già iniziato a informarsi su altri professionisti non significa tradire o svalutare il lavoro fatto finora, ma prendersi cura di sé in un momento di particolare vulnerabilità, anche considerando l’intervento chirurgico imminente e lo stato di iperallerta che descrive.
Forse, più che decidere subito se “continuare o cambiare”, potrebbe essere utile chiedersi: “mi sentirei in grado di tornare da lei e parlarle di ciò che ho provato senza sentirmi di nuovo in pericolo? Oppure, in questo momento, avrei bisogno di uno spazio nuovo, più contenitivo, che mi aiuti a ristabilire una base di sicurezza?”.
Qualunque scelta farà, interrompere una terapia non la rende ingrata, sbagliata o irresponsabile. I percorsi possono anche concludersi quando non sono più sostenibili, e questo non cancella il lavoro fatto né il valore dell’impegno che lei ha messo in questi anni.
Si conceda il diritto di ascoltarsi, senza forzarsi per senso di colpa. La terapia dovrebbe essere un luogo in cui, pur nel confronto e nella fatica, ci si sente protetti.
Resto a disposizione per ulteriori approfondimenti.
Un caro saluto, dott.ssa Martina Veracini

Buongiorno,
non è facile rispondere a questa domanda e di sicuro non voglio giudicare l'operato della collega di cui non conosco nè le cause nè le modalità se non attraverso il suo racconto. Credo tuttavia che lei abbia il diritto di sentirsi al sicuro nella stanza di terapia. Se non è così, forse davvero può valere la pena provare altro. Non tutti i terapeuti sono giusti per tutti i pazienti e non c'è nulla di strano in questo.
Cordiali saluti,
dott.ssa Marianna Mansueto
non è facile rispondere a questa domanda e di sicuro non voglio giudicare l'operato della collega di cui non conosco nè le cause nè le modalità se non attraverso il suo racconto. Credo tuttavia che lei abbia il diritto di sentirsi al sicuro nella stanza di terapia. Se non è così, forse davvero può valere la pena provare altro. Non tutti i terapeuti sono giusti per tutti i pazienti e non c'è nulla di strano in questo.
Cordiali saluti,
dott.ssa Marianna Mansueto
Buonasera, grazie per la fiducia con cui hai condiviso qualcosa di così delicato.
È un episodio delicato quello che hai descritto.. Sentirsi minacciata o spaventata, in un contesto dove dovresti poterti aprire, è un segnale da non ignorare.
Il transfert e il controtransfert sono elementi naturali in psicoterapia, e tu hai mostrato un ottimo livello di consapevolezza nell’individuarli e nel riflettere sul loro impatto. Anche se la tua terapeuta ha riconosciuto il controtransfert e ha cercato di spiegarsi, la responsabilità resta sua: è suo compito gestire le proprie reazioni, proteggere lo spazio terapeutico e garantirti sicurezza emotiva e fisica.
Non è insolito provare senso di colpa quando si interrompe una relazione terapeutica. Ma interrompere un percorso che ti fa sentire esposta o minacciata non significa "abbandonare", significa proteggere te stessa.
Hai fatto bene a pensare a un’alternativa. Iniziare con un nuovo terapeuta, magari con un approccio diverso, può essere l’occasione per costruire una relazione più stabile, empatica e rispettosa dei tuoi tempi. L’iper-vigilanza che provi, la diffidenza, la fatica a fidarti: sono aspetti importanti che possono (e devono) essere accolti con pazienza e rispetto, non con aggressività.
Il tuo non è un drop-out impulsivo: è una decisione ponderata davanti a qualcosa che ha compromesso la tua sicurezza. E questo non ti rende una “paziente difficile”, ti rende una persona che ha diritto ad essere tutelata.
È un episodio delicato quello che hai descritto.. Sentirsi minacciata o spaventata, in un contesto dove dovresti poterti aprire, è un segnale da non ignorare.
Il transfert e il controtransfert sono elementi naturali in psicoterapia, e tu hai mostrato un ottimo livello di consapevolezza nell’individuarli e nel riflettere sul loro impatto. Anche se la tua terapeuta ha riconosciuto il controtransfert e ha cercato di spiegarsi, la responsabilità resta sua: è suo compito gestire le proprie reazioni, proteggere lo spazio terapeutico e garantirti sicurezza emotiva e fisica.
Non è insolito provare senso di colpa quando si interrompe una relazione terapeutica. Ma interrompere un percorso che ti fa sentire esposta o minacciata non significa "abbandonare", significa proteggere te stessa.
Hai fatto bene a pensare a un’alternativa. Iniziare con un nuovo terapeuta, magari con un approccio diverso, può essere l’occasione per costruire una relazione più stabile, empatica e rispettosa dei tuoi tempi. L’iper-vigilanza che provi, la diffidenza, la fatica a fidarti: sono aspetti importanti che possono (e devono) essere accolti con pazienza e rispetto, non con aggressività.
Il tuo non è un drop-out impulsivo: è una decisione ponderata davanti a qualcosa che ha compromesso la tua sicurezza. E questo non ti rende una “paziente difficile”, ti rende una persona che ha diritto ad essere tutelata.

Buonasera,
la ringrazio per aver condiviso un’esperienza così delicata: da ciò che descrive emergono molta consapevolezza di sé, un grande lavoro introspettivo e, allo stesso tempo, una situazione che l’ha fatta sentire spaventata e non al sicuro.
È importante chiarire un punto centrale: in psicoterapia la sicurezza emotiva e fisica del paziente è un presupposto imprescindibile. Indipendentemente dal modello teorico (psicoanalitico o altro), una reazione come quella che descrive — urla, avvicinamento fisico percepito come minaccioso, tentativo di impedirle di andare via — può essere vissuta come fortemente destabilizzante, soprattutto in una persona con una storia di traumi, ipervigilanza e familiarità con dinamiche di aggressività verbale. Il fatto che lei si sia sentita in pericolo è un dato clinico da prendere molto seriamente, non una “esagerazione”.
Il controtransfert è un fenomeno reale e studiato, ma riconoscerlo non equivale a giustificare un agito. Quando il controtransfert porta a comportamenti che travolgono il paziente invece di contenerlo, è responsabilità del terapeuta fermarsi, riflettere e, se necessario, portare il proprio vissuto in supervisione. “Scuotere” un paziente attraverso urla o modalità intrusive, soprattutto sapendo che tali stimoli riattivano blocco e paura, non è generalmente considerato terapeutico.
È comprensibile che ora lei provi:
un blocco nei confronti della terapeuta,
senso di colpa per l’interruzione improvvisa,
e confusione sul da farsi.
Il senso di colpa, in questi casi, è frequente, ma va ricordato che interrompere una seduta o una terapia quando non ci si sente al sicuro è un diritto del paziente, non una mancanza. Non esistono “pazienti difficili” in senso colpevolizzante: esistono storie complesse che richiedono setting, tempi e modalità adeguate. Anche la fase di vita che sta attraversando (attesa di un intervento chirurgico importante) può aumentare la vulnerabilità e rendere ancora più necessario un contesto terapeutico altamente contenitivo.
Alla sua domanda: è utile continuare o è meglio cambiare?
Quando la fiducia di base e il senso di sicurezza vengono compromessi a questo livello, proseguire il lavoro diventa molto difficile, se non impossibile. In alcuni casi può essere utile un ultimo colloquio di chiarimento; in altri, il cambio di terapeuta rappresenta una scelta di tutela e non un fallimento. Il fatto che lei stia già valutando alternative indica una buona capacità di prendersi cura di sé.
Il mio consiglio è di approfondire questa esperienza con uno specialista, anche solo per rielaborare quanto accaduto e capire quale tipo di percorso e di setting possano essere per lei più adatti in questa fase. Questo le permetterà di fare una scelta non guidata dalla paura o dal senso di colpa, ma dal suo reale benessere.
Un caro saluto,
Dottoressa Silvia Parisi
Psicologa – Psicoterapeuta – Sessuologa
la ringrazio per aver condiviso un’esperienza così delicata: da ciò che descrive emergono molta consapevolezza di sé, un grande lavoro introspettivo e, allo stesso tempo, una situazione che l’ha fatta sentire spaventata e non al sicuro.
È importante chiarire un punto centrale: in psicoterapia la sicurezza emotiva e fisica del paziente è un presupposto imprescindibile. Indipendentemente dal modello teorico (psicoanalitico o altro), una reazione come quella che descrive — urla, avvicinamento fisico percepito come minaccioso, tentativo di impedirle di andare via — può essere vissuta come fortemente destabilizzante, soprattutto in una persona con una storia di traumi, ipervigilanza e familiarità con dinamiche di aggressività verbale. Il fatto che lei si sia sentita in pericolo è un dato clinico da prendere molto seriamente, non una “esagerazione”.
Il controtransfert è un fenomeno reale e studiato, ma riconoscerlo non equivale a giustificare un agito. Quando il controtransfert porta a comportamenti che travolgono il paziente invece di contenerlo, è responsabilità del terapeuta fermarsi, riflettere e, se necessario, portare il proprio vissuto in supervisione. “Scuotere” un paziente attraverso urla o modalità intrusive, soprattutto sapendo che tali stimoli riattivano blocco e paura, non è generalmente considerato terapeutico.
È comprensibile che ora lei provi:
un blocco nei confronti della terapeuta,
senso di colpa per l’interruzione improvvisa,
e confusione sul da farsi.
Il senso di colpa, in questi casi, è frequente, ma va ricordato che interrompere una seduta o una terapia quando non ci si sente al sicuro è un diritto del paziente, non una mancanza. Non esistono “pazienti difficili” in senso colpevolizzante: esistono storie complesse che richiedono setting, tempi e modalità adeguate. Anche la fase di vita che sta attraversando (attesa di un intervento chirurgico importante) può aumentare la vulnerabilità e rendere ancora più necessario un contesto terapeutico altamente contenitivo.
Alla sua domanda: è utile continuare o è meglio cambiare?
Quando la fiducia di base e il senso di sicurezza vengono compromessi a questo livello, proseguire il lavoro diventa molto difficile, se non impossibile. In alcuni casi può essere utile un ultimo colloquio di chiarimento; in altri, il cambio di terapeuta rappresenta una scelta di tutela e non un fallimento. Il fatto che lei stia già valutando alternative indica una buona capacità di prendersi cura di sé.
Il mio consiglio è di approfondire questa esperienza con uno specialista, anche solo per rielaborare quanto accaduto e capire quale tipo di percorso e di setting possano essere per lei più adatti in questa fase. Questo le permetterà di fare una scelta non guidata dalla paura o dal senso di colpa, ma dal suo reale benessere.
Un caro saluto,
Dottoressa Silvia Parisi
Psicologa – Psicoterapeuta – Sessuologa
Buonasera, grazie per aver scritto e per aver raccontato un episodio così delicato. Da quello che descrivi emerge soprattutto un’esperienza di forte paura e di perdita di sicurezza, più ancora di un dubbio teorico o di una valutazione “giusta o sbagliata”.
Provo a restare con ciò che hai vissuto, senza dare verdetti.
Nel momento in cui una persona a cui ti affidi alza la voce, si avvicina fisicamente, invade lo spazio, qualcosa di profondo può attivarsi, soprattutto se nella tua storia le urla sono state associate a minaccia, blocco, impotenza. In quei momenti non è una questione di interpretazione o di intenzioni: il corpo reagisce prima delle spiegazioni. E il tuo corpo, da come lo racconti, ha reagito cercando di proteggerti.
Forse la domanda non è tanto se lei intendesse aiutarti, scuoterti o lavorare su qualcosa, ma che cosa è successo dentro di te in quel preciso istante. Ti sei sentita ascoltata o sopraffatta? Al sicuro o in pericolo? Presente o congelata? Queste sensazioni sono informazioni preziose, non esagerazioni.
Dici anche qualcosa di importante: “non sono una paziente facile, sono diffidente, faccio perdere la pazienza”. Vale la pena fermarsi un attimo su questa frase. Potrebbe essere una descrizione, ma potrebbe anche essere uno sguardo severo che hai imparato a rivolgere a te stessa, soprattutto quando senti di “disturbare” o di creare difficoltà all’altro. E allora nasce il senso di colpa, anche quando sei tu ad aver avuto paura.
Ti senti in colpa per aver interrotto improvvisamente, ma allo stesso tempo dici che ora hai un blocco nei suoi confronti. Il blocco spesso non è una scelta razionale: è un segnale. Non dice necessariamente “non continuare mai più”, ma dice “così, in questo modo, io non riesco ad andare avanti”.
C’è anche un altro elemento che attraversa il tuo racconto: l’iper-vigilanza, l’attesa di un intervento importante, il corpo già sotto stress. In questi periodi le soglie si abbassano: ciò che prima poteva forse essere tollerato, ora diventa insostenibile. Non per debolezza, ma perché le risorse sono già impegnate altrove.
Forse, invece di chiederti se devi continuare o devi cambiare, potresti porti domande leggermente diverse:
– oggi, in questo momento della mia vita, riesco a rientrare in quella stanza sentendomi sufficientemente al sicuro?
– se continuassi, sarebbe per desiderio di capire o per senso di colpa?
– che cosa sto proteggendo interrompendo, e che cosa rischierei forzandomi a restare?
Il senso di colpa che provi parla della tua attenzione all’altro, della tua capacità di legarti. Ma la cura, qualunque forma prenda, non può basarsi sulla paura o sull’obbligo. Se c’è spazio, un confronto chiarificatore può avere senso; se quello spazio ora non c’è, anche fermarsi è una forma di rispetto verso te stessa.
Non sembra che tu stia “scappando”. Sembra piuttosto che tu stia cercando di capire dove puoi stare senza doverti difendere continuamente. E questa non è una domanda semplice, né sbagliata. È una domanda che merita tempo, e soprattutto gentilezza verso di te.
Provo a restare con ciò che hai vissuto, senza dare verdetti.
Nel momento in cui una persona a cui ti affidi alza la voce, si avvicina fisicamente, invade lo spazio, qualcosa di profondo può attivarsi, soprattutto se nella tua storia le urla sono state associate a minaccia, blocco, impotenza. In quei momenti non è una questione di interpretazione o di intenzioni: il corpo reagisce prima delle spiegazioni. E il tuo corpo, da come lo racconti, ha reagito cercando di proteggerti.
Forse la domanda non è tanto se lei intendesse aiutarti, scuoterti o lavorare su qualcosa, ma che cosa è successo dentro di te in quel preciso istante. Ti sei sentita ascoltata o sopraffatta? Al sicuro o in pericolo? Presente o congelata? Queste sensazioni sono informazioni preziose, non esagerazioni.
Dici anche qualcosa di importante: “non sono una paziente facile, sono diffidente, faccio perdere la pazienza”. Vale la pena fermarsi un attimo su questa frase. Potrebbe essere una descrizione, ma potrebbe anche essere uno sguardo severo che hai imparato a rivolgere a te stessa, soprattutto quando senti di “disturbare” o di creare difficoltà all’altro. E allora nasce il senso di colpa, anche quando sei tu ad aver avuto paura.
Ti senti in colpa per aver interrotto improvvisamente, ma allo stesso tempo dici che ora hai un blocco nei suoi confronti. Il blocco spesso non è una scelta razionale: è un segnale. Non dice necessariamente “non continuare mai più”, ma dice “così, in questo modo, io non riesco ad andare avanti”.
C’è anche un altro elemento che attraversa il tuo racconto: l’iper-vigilanza, l’attesa di un intervento importante, il corpo già sotto stress. In questi periodi le soglie si abbassano: ciò che prima poteva forse essere tollerato, ora diventa insostenibile. Non per debolezza, ma perché le risorse sono già impegnate altrove.
Forse, invece di chiederti se devi continuare o devi cambiare, potresti porti domande leggermente diverse:
– oggi, in questo momento della mia vita, riesco a rientrare in quella stanza sentendomi sufficientemente al sicuro?
– se continuassi, sarebbe per desiderio di capire o per senso di colpa?
– che cosa sto proteggendo interrompendo, e che cosa rischierei forzandomi a restare?
Il senso di colpa che provi parla della tua attenzione all’altro, della tua capacità di legarti. Ma la cura, qualunque forma prenda, non può basarsi sulla paura o sull’obbligo. Se c’è spazio, un confronto chiarificatore può avere senso; se quello spazio ora non c’è, anche fermarsi è una forma di rispetto verso te stessa.
Non sembra che tu stia “scappando”. Sembra piuttosto che tu stia cercando di capire dove puoi stare senza doverti difendere continuamente. E questa non è una domanda semplice, né sbagliata. È una domanda che merita tempo, e soprattutto gentilezza verso di te.

Gentile signora,
sono dispiaciuto per il suo vissuto. Per il problema medico che descrive penso che come me non sia più giovane, dunque avrebbe più che diritto ad essere trattata con delicatezza e rispetto, ed a raggiungere un buon benessere.
Dunque le scrivo quello che penso, ma credo che la maggioranza dei colleghi potrebbe sottoscrivere.
Ho molto rispetto ed apprezzamento per il corpo di conoscenze della psicoanalisi. Ma credo che una terapia non debba durare anni. Altrimenti diviene un sostegno, uno sfogatoio. La terapia è altro. C'è un problema e noi mettiamo in atto gli strumenti più adeguati per risolverlo od alleviarlo. Ci può volere del tempo, ma se dopo un anno non si raggiunge un buon miglioramento io per primo consiglio al paziente di rivolgersi ad altro terapeuta. Ci sono tecniche moderne per trattare i traumi come l' EMDR che agiscono in pochi mesi. Per la depressione, se dopo alcuni mesi non migliora è opportuno un intervento farmacologico od anche con terapie naturali (fitoterapia, vitamine e altro). E' gravemente scorretto perdere la pazienza o peggio urlare. Si può parlare in modo sostenuto o a voce alta ma senza incutere spavento. Il mio consiglio è senz'altro di cambiare terapeuta. E non si senta in colpa: il suo benessere (che purtroppo ancora non è raggiunto) vale infinitamente di più di un eventuale dispiacere della terapista che temo sia sopratutto economico! Ci pensi.. I miei più sinceri auguri. dr. Tacchini
sono dispiaciuto per il suo vissuto. Per il problema medico che descrive penso che come me non sia più giovane, dunque avrebbe più che diritto ad essere trattata con delicatezza e rispetto, ed a raggiungere un buon benessere.
Dunque le scrivo quello che penso, ma credo che la maggioranza dei colleghi potrebbe sottoscrivere.
Ho molto rispetto ed apprezzamento per il corpo di conoscenze della psicoanalisi. Ma credo che una terapia non debba durare anni. Altrimenti diviene un sostegno, uno sfogatoio. La terapia è altro. C'è un problema e noi mettiamo in atto gli strumenti più adeguati per risolverlo od alleviarlo. Ci può volere del tempo, ma se dopo un anno non si raggiunge un buon miglioramento io per primo consiglio al paziente di rivolgersi ad altro terapeuta. Ci sono tecniche moderne per trattare i traumi come l' EMDR che agiscono in pochi mesi. Per la depressione, se dopo alcuni mesi non migliora è opportuno un intervento farmacologico od anche con terapie naturali (fitoterapia, vitamine e altro). E' gravemente scorretto perdere la pazienza o peggio urlare. Si può parlare in modo sostenuto o a voce alta ma senza incutere spavento. Il mio consiglio è senz'altro di cambiare terapeuta. E non si senta in colpa: il suo benessere (che purtroppo ancora non è raggiunto) vale infinitamente di più di un eventuale dispiacere della terapista che temo sia sopratutto economico! Ci pensi.. I miei più sinceri auguri. dr. Tacchini

La terapia non è un percorso accomodante né sempre rassicurante, richiede fiducia nella relazione terapeutica e la disponibilità a sostare anche nei momenti difficili.
Quanto è accaduto in seduta ha certamente un significato all’interno del lavoro terapeutico e immagino che anche la sua reazione, come ha spiegato, abbia avuto per lei un valore preciso. In questo momento avverte un blocco, ma è importante accettare che l’unico modo per attraversarlo e comprenderlo davvero sia continuare il percorso, dando spazio a ciò che è emerso, piuttosto che interromperlo proprio nel pieno della difficoltà.
Credo che solo restando all’interno della relazione terapeutica sia possibile trasformare quanto accaduto in qualcosa di utile per il lavoro analitico. Resto quindi curiosa rispetto a ciò che potrà emergere proseguendo il percorso, con l’augurio dei migliori sviluppi per lei.
Quanto è accaduto in seduta ha certamente un significato all’interno del lavoro terapeutico e immagino che anche la sua reazione, come ha spiegato, abbia avuto per lei un valore preciso. In questo momento avverte un blocco, ma è importante accettare che l’unico modo per attraversarlo e comprenderlo davvero sia continuare il percorso, dando spazio a ciò che è emerso, piuttosto che interromperlo proprio nel pieno della difficoltà.
Credo che solo restando all’interno della relazione terapeutica sia possibile trasformare quanto accaduto in qualcosa di utile per il lavoro analitico. Resto quindi curiosa rispetto a ciò che potrà emergere proseguendo il percorso, con l’augurio dei migliori sviluppi per lei.

Buonasera, ha fatto molto bene a scrivere e a condividere questa situazione che immagino l'abbia spaventata e confusa profondamente. Proverò a risponderle con la massima chiarezza, anche se per la complessità della situazione e per il suo benessere sarebbe importante trovare al più presto un supporto professionale sicuro e competente.
E' da specificare subito, quello che è accaduto durante l'ultima seduta non è accettabile dal punto di vista clinico ed deontologico e la sua decisione di interrompere il percorso con questa professionista non solo è legittima, ma pare essere una scelta protettiva e sana per lei.
Quello che descrive rappresenta una violazione grave dei confini terapeutici e dei principi fondamentali della relazione di cura. NON esistono prove affidabili a livello scientifico che un comportamento simile possa avere qualche valenza clinica. Inoltre lei conosce oramai da molto questa terapeuta, 6 anni non sono pochi, al dilà del setting della psicanalisi, è un percorso già mediamente lungo, se si sente bloccata e è accaduto tutto ciò faccia quel che la fa sentire meglio e piuttosto interrompa. E' SEMPRE diritto del paziente interrompere in qualunque caso.
In qualunque approccio terapeutico, inclusa la psicoanalisi, il setting deve garantire: LA sicurezza fisica ed emotiva della paziente, l rispetto dell'autonomia e la sua valorizzazione, sottolineando che lei ha il diritto di andare e concludere SEMPRE. Inoltre è importante l'astensione da comportamenti intimidatori o aggressivi che ripeto, non hanno alcuna evidenza di efficacia.
La spiegazione post-hoc della terapeuta ("è stato controtransfert", "volevo scuoterti dal torpore") non giustifica quello che è accaduto. Il controtransfert è un fenomeno normale in terapia, ma va riconosciuto e gestito dal terapeuta in supervisione o nella propria analisi personale, non "agito" sulla paziente, soprattutto in modo aggressivo. E soprattutto: lei stessa le aveva comunicato che le urla la bloccano , quindi riprodurre proprio quella dinamica non può essere considerato "terapeutico".
Quello che sta provando ora è comprensibile
Lei descrive paura, blocco verso la terapeuta, ma anche senso di colpa per aver interrotto. Questo è molto comprensibile e coerente con la sua storia: quando si cresce in famiglie disfunzionali con figure che urlano o violano confini, spesso si impara a pensare che la colpa sia propria, anche quando l'altro ha comportamenti inappropriati.
Cerchi un nuovo professionista o mediti un periodo di pausa dalla terapia, molto spesso nei percorsi più lunghi si sviluppa quasi una "dipendenza" dal terapeuta. A volte bisogna solo parlare l'esperienza e si riesce ad andare avanti con gli strumenti sviluppati in terapia (se è stata bene fatta e funzionale) e se tutto è troppo difficile, ad iniziare un nuovo percorso ci mette poco.
Spero di essere stato d'aiuto,
Dott. Marco Scaramuzzino
E' da specificare subito, quello che è accaduto durante l'ultima seduta non è accettabile dal punto di vista clinico ed deontologico e la sua decisione di interrompere il percorso con questa professionista non solo è legittima, ma pare essere una scelta protettiva e sana per lei.
Quello che descrive rappresenta una violazione grave dei confini terapeutici e dei principi fondamentali della relazione di cura. NON esistono prove affidabili a livello scientifico che un comportamento simile possa avere qualche valenza clinica. Inoltre lei conosce oramai da molto questa terapeuta, 6 anni non sono pochi, al dilà del setting della psicanalisi, è un percorso già mediamente lungo, se si sente bloccata e è accaduto tutto ciò faccia quel che la fa sentire meglio e piuttosto interrompa. E' SEMPRE diritto del paziente interrompere in qualunque caso.
In qualunque approccio terapeutico, inclusa la psicoanalisi, il setting deve garantire: LA sicurezza fisica ed emotiva della paziente, l rispetto dell'autonomia e la sua valorizzazione, sottolineando che lei ha il diritto di andare e concludere SEMPRE. Inoltre è importante l'astensione da comportamenti intimidatori o aggressivi che ripeto, non hanno alcuna evidenza di efficacia.
La spiegazione post-hoc della terapeuta ("è stato controtransfert", "volevo scuoterti dal torpore") non giustifica quello che è accaduto. Il controtransfert è un fenomeno normale in terapia, ma va riconosciuto e gestito dal terapeuta in supervisione o nella propria analisi personale, non "agito" sulla paziente, soprattutto in modo aggressivo. E soprattutto: lei stessa le aveva comunicato che le urla la bloccano , quindi riprodurre proprio quella dinamica non può essere considerato "terapeutico".
Quello che sta provando ora è comprensibile
Lei descrive paura, blocco verso la terapeuta, ma anche senso di colpa per aver interrotto. Questo è molto comprensibile e coerente con la sua storia: quando si cresce in famiglie disfunzionali con figure che urlano o violano confini, spesso si impara a pensare che la colpa sia propria, anche quando l'altro ha comportamenti inappropriati.
Cerchi un nuovo professionista o mediti un periodo di pausa dalla terapia, molto spesso nei percorsi più lunghi si sviluppa quasi una "dipendenza" dal terapeuta. A volte bisogna solo parlare l'esperienza e si riesce ad andare avanti con gli strumenti sviluppati in terapia (se è stata bene fatta e funzionale) e se tutto è troppo difficile, ad iniziare un nuovo percorso ci mette poco.
Spero di essere stato d'aiuto,
Dott. Marco Scaramuzzino
Buonasera,
la ringrazio per aver trovato il coraggio di raccontare una situazione così delicata. Da quello che descrive emergono molti elementi importanti, e il primo è il forte stato emotivo di allarme e insicurezza che ha vissuto durante l’ultima seduta. Questo merita di essere preso molto sul serio.
In una relazione terapeutica, qualunque sia l’orientamento teorico, la percezione di sicurezza è un prerequisito fondamentale. Il fatto che lei si sia sentita spaventata, non più al sicuro, al punto da temere un possibile agito fisico, è un segnale che non va minimizzato né attribuito semplicemente a un’esagerazione o a una sua “difficoltà caratteriale”. Anche quando entrano in gioco dinamiche di transfert e controtransfert – che fanno parte del lavoro clinico – la responsabilità della loro gestione resta sempre del terapeuta, soprattutto quando il paziente ha una storia di traumi, urla familiari e blocco emotivo legato a esperienze di sopraffazione.
Il controtransfert può certamente attivarsi, ma non giustifica modalità che risultano intrusive, spaventanti o destabilizzanti, soprattutto se il terapeuta è consapevole che determinati comportamenti (come l’urlare) per lei hanno un effetto traumatico e paralizzante. Il fatto che lei abbia riconosciuto lucidamente il transfert negativo, che abbia provato a mentalizzare l’accaduto e che oggi si stia interrogando sul senso di continuare o meno, parla di una grande capacità riflessiva, non di una “paziente difficile”.
È comprensibile anche il senso di colpa che descrive: spesso chi ha storie familiari complesse tende a farsi carico del benessere dell’altro, anche quando sta male, e a chiedersi se non stia “esagerando”. Allo stesso tempo, il suo corpo e le sue emozioni sembrano aver lanciato un messaggio molto chiaro: qualcosa, in quel momento, è stato vissuto come troppo. E questo messaggio è legittimo, indipendentemente dalle spiegazioni teoriche che possono essere date a posteriori.
In questi casi, più che chiedersi se “sia giusto” fare drop-out, forse può essere utile spostare la domanda su un altro piano: questa relazione terapeutica, oggi, è ancora un luogo in cui posso sentirmi al sicuro per esplorare il mio dolore, oppure no?
A volte, dopo molti anni di lavoro, può essere necessario fermarsi, rinegoziare o anche cambiare terapeuta non come fallimento, ma come passaggio evolutivo, soprattutto se il contesto personale rende alcune dinamiche ancora più sensibili.
Un percorso di psicoterapia serve proprio a dare senso a ciò che accade tra le persone, alle emozioni che si attivano, ai blocchi, alla paura, al senso di colpa, collocandoli nella propria storia e nel momento di vita che si sta attraversando. Farlo in un contesto in cui ci si sente ascoltati e rispettati è essenziale.
Forse la riflessione che può accompagnarla ora è:
-di cosa ho bisogno, in questo momento della mia vita, da una relazione terapeutica per potermi sentire sufficientemente protetta da continuare a lavorare su di me?
Se sentirà il bisogno di approfondire questi aspetti o di essere accompagnata nel comprendere meglio cosa le è successo – dentro e fuori da quella stanza – rimango a disposizione per ulteriori informazioni o per valutare insieme l’avvio di un nuovo percorso, con i tempi e i modi che per lei possano essere più sostenibili.
la ringrazio per aver trovato il coraggio di raccontare una situazione così delicata. Da quello che descrive emergono molti elementi importanti, e il primo è il forte stato emotivo di allarme e insicurezza che ha vissuto durante l’ultima seduta. Questo merita di essere preso molto sul serio.
In una relazione terapeutica, qualunque sia l’orientamento teorico, la percezione di sicurezza è un prerequisito fondamentale. Il fatto che lei si sia sentita spaventata, non più al sicuro, al punto da temere un possibile agito fisico, è un segnale che non va minimizzato né attribuito semplicemente a un’esagerazione o a una sua “difficoltà caratteriale”. Anche quando entrano in gioco dinamiche di transfert e controtransfert – che fanno parte del lavoro clinico – la responsabilità della loro gestione resta sempre del terapeuta, soprattutto quando il paziente ha una storia di traumi, urla familiari e blocco emotivo legato a esperienze di sopraffazione.
Il controtransfert può certamente attivarsi, ma non giustifica modalità che risultano intrusive, spaventanti o destabilizzanti, soprattutto se il terapeuta è consapevole che determinati comportamenti (come l’urlare) per lei hanno un effetto traumatico e paralizzante. Il fatto che lei abbia riconosciuto lucidamente il transfert negativo, che abbia provato a mentalizzare l’accaduto e che oggi si stia interrogando sul senso di continuare o meno, parla di una grande capacità riflessiva, non di una “paziente difficile”.
È comprensibile anche il senso di colpa che descrive: spesso chi ha storie familiari complesse tende a farsi carico del benessere dell’altro, anche quando sta male, e a chiedersi se non stia “esagerando”. Allo stesso tempo, il suo corpo e le sue emozioni sembrano aver lanciato un messaggio molto chiaro: qualcosa, in quel momento, è stato vissuto come troppo. E questo messaggio è legittimo, indipendentemente dalle spiegazioni teoriche che possono essere date a posteriori.
In questi casi, più che chiedersi se “sia giusto” fare drop-out, forse può essere utile spostare la domanda su un altro piano: questa relazione terapeutica, oggi, è ancora un luogo in cui posso sentirmi al sicuro per esplorare il mio dolore, oppure no?
A volte, dopo molti anni di lavoro, può essere necessario fermarsi, rinegoziare o anche cambiare terapeuta non come fallimento, ma come passaggio evolutivo, soprattutto se il contesto personale rende alcune dinamiche ancora più sensibili.
Un percorso di psicoterapia serve proprio a dare senso a ciò che accade tra le persone, alle emozioni che si attivano, ai blocchi, alla paura, al senso di colpa, collocandoli nella propria storia e nel momento di vita che si sta attraversando. Farlo in un contesto in cui ci si sente ascoltati e rispettati è essenziale.
Forse la riflessione che può accompagnarla ora è:
-di cosa ho bisogno, in questo momento della mia vita, da una relazione terapeutica per potermi sentire sufficientemente protetta da continuare a lavorare su di me?
Se sentirà il bisogno di approfondire questi aspetti o di essere accompagnata nel comprendere meglio cosa le è successo – dentro e fuori da quella stanza – rimango a disposizione per ulteriori informazioni o per valutare insieme l’avvio di un nuovo percorso, con i tempi e i modi che per lei possano essere più sostenibili.
Buonasera, la situazione che Lei descrive è molto delicata e merita di essere affrontata con attenzione, senza minimizzare ciò che è accaduto ma nemmeno forzare una conclusione affrettata. Il punto centrale non è stabilire se la reazione della terapeuta sia stata “tecnicamente” giustificabile o spiegabile attraverso concetti teorici, ma l’effetto che ha avuto su di Lei. Lei racconta di essersi sentita spaventata, non al sicuro, bloccata, e questo dato va preso sul serio. In un lavoro di questo tipo, la possibilità di sentirsi sufficientemente protetti nello spazio della seduta è una condizione imprescindibile, soprattutto quando sono presenti una storia di urla familiari e uno stato di iper vigilanza legato anche alla situazione medica che sta attraversando. Lei tende a interrogarsi molto su sé stessa, sul fatto di essere “difficile”, diffidente, di far perdere la pazienza agli altri, e questo rischio di spostare tutto su una Sua colpa personale è comprensibile, ma va messo in discussione. Anche se una persona è complessa, fragile o attraversa momenti di grande tensione, resta fondamentale che lo spazio di parola non diventi un luogo in cui il corpo viene nuovamente esposto a una minaccia, anche solo percepita. Il senso di colpa che prova ora può essere letto come l’effetto di una rottura improvvisa di un legame importante, più che come la prova che Lei abbia sbagliato. Allo stesso tempo, il blocco che sente nei confronti della terapeuta indica che qualcosa si è incrinato e che oggi non riesce più a portare lì la Sua parola con libertà. Continuare o cambiare non è una decisione che può essere presa sulla base di un dovere morale o della paura di “fare drop out”, ma a partire da una domanda più semplice e più vera: in questo momento, quello spazio è ancora abitabile per Lei oppure no. Nel mio modo di lavorare si dà grande importanza a rispettare i tempi del soggetto e a non forzare la prosecuzione di un percorso quando si è prodotto uno scarto così forte sul piano della sicurezza e della fiducia. Talvolta fermarsi, prendere distanza o interrogare un’altra possibilità non significa buttare via il lavoro fatto, ma riconoscere che una fase è arrivata a un limite.
La saluto cordialmente, dottoressa Laura Lanocita.
La saluto cordialmente, dottoressa Laura Lanocita.
Gentile utente,
la ringrazio per aver trovato il coraggio di condividere un’esperienza così delicata e dolorosa. Da ciò che scrive emerge con molta chiarezza quanto lei sia una persona riflessiva, consapevole dei propri funzionamenti interni e profondamente coinvolta nel lavoro terapeutico che sta portando avanti da anni. Questo, di per sé, è già un elemento di grande valore.
Quello che descrive rispetto all’ultima seduta è un vissuto di forte spavento e perdita di sicurezza. Al di là delle spiegazioni teoriche che possono essere date (transfert, controtransfert, tentativi di “scuotere”), c’è un punto clinico fondamentale che non può essere ignorato: una seduta terapeutica deve restare, in ogni momento, uno spazio sufficientemente sicuro. Quando una persona in terapia – soprattutto con una storia di traumi e figure genitoriali intrusive o urlanti – si sente minacciata, bloccata o teme per la propria incolumità, qualcosa di essenziale nel setting si è incrinato.
È molto importante sottolineare questo:
il fatto che lei abbia percepito paura non è una sua esagerazione, né una prova di essere “una paziente difficile”. È una reazione coerente con la sua storia, con il suo attuale stato di ipervigilanza e con ciò che è accaduto in seduta. In terapia non è il paziente che deve “reggere” l’intensità dell’intervento del terapeuta, ma è il terapeuta che ha la responsabilità di modulare il proprio intervento sulla base della struttura e della vulnerabilità della persona che ha davanti.
Il controtransfert esiste, ed è vero che può diventare uno strumento di comprensione clinica. Tuttavia, non tutto ciò che nasce dal controtransfert è automaticamente terapeutico. Quando un agito – come urlare, avvicinarsi fisicamente in modo percepito come minaccioso, impedire simbolicamente l’uscita – provoca riattivazione traumatica, blocco e paura, quel controtransfert necessita di essere elaborato dal terapeuta, non messo in atto sul paziente.
Mi colpisce molto la sua capacità di tenere insieme più livelli:
– la consapevolezza del transfert negativo
– il senso di colpa per l’interruzione
– la preoccupazione di “non essere facile”
– e allo stesso tempo il bisogno di proteggersi
Questo senso di colpa è comprensibile, ma è importante chiarire un punto: lei non deve prendersi cura della sua terapeuta, né proteggerla dal dolore di un’interruzione. La responsabilità della relazione terapeutica è sempre condivisa, ma la responsabilità del setting e della sicurezza emotiva resta del professionista.
Rispetto alla sua domanda centrale – continuare o cambiare? – più che darle una risposta netta, le propongo un criterio clinico:
in questo momento lei si sente bloccata, spaventata e non più al sicuro con questa terapeuta. In queste condizioni, la terapia difficilmente può proseguire in modo efficace, almeno senza una profonda riparazione dell’alleanza.
A volte può essere utile prevedere una seduta di chiarificazione o di chiusura, se e solo se lei si sente sufficientemente tutelata, per poter dare un senso a quanto accaduto e non vivere l’interruzione come un fallimento. Ma non è un obbligo.
Il fatto che lei stia già cercando alternative non è una fuga: è un atto di cura verso se stessa, soprattutto in una fase di grande fragilità fisica ed emotiva come quella che sta attraversando in vista dell’intervento chirurgico.
In conclusione, vorrei lasciarle un messaggio chiaro e fermo:
lei ha il diritto di scegliere un percorso terapeutico in cui si senta ascoltata, rispettata e al sicuro. Cambiare terapeuta non cancella il lavoro fatto in sei anni, né la rende incoerente o ingrata. A volte, proprio grazie a un’esperienza dolorosa, diventa possibile fare un passo più aderente ai propri bisogni profondi.
Se lo desidera, un nuovo percorso potrebbe anche aiutarla a rileggere questa esperienza non come un fallimento, ma come un passaggio evolutivo importante nella sua storia di cura.
Resto a disposizione per eventuali approfondimenti.
Un caro saluto,
Dott.ssa Caterina Lo Bianco – Psicologa clinica, Psicologa ad orientamento Sistemico-Relazionale
la ringrazio per aver trovato il coraggio di condividere un’esperienza così delicata e dolorosa. Da ciò che scrive emerge con molta chiarezza quanto lei sia una persona riflessiva, consapevole dei propri funzionamenti interni e profondamente coinvolta nel lavoro terapeutico che sta portando avanti da anni. Questo, di per sé, è già un elemento di grande valore.
Quello che descrive rispetto all’ultima seduta è un vissuto di forte spavento e perdita di sicurezza. Al di là delle spiegazioni teoriche che possono essere date (transfert, controtransfert, tentativi di “scuotere”), c’è un punto clinico fondamentale che non può essere ignorato: una seduta terapeutica deve restare, in ogni momento, uno spazio sufficientemente sicuro. Quando una persona in terapia – soprattutto con una storia di traumi e figure genitoriali intrusive o urlanti – si sente minacciata, bloccata o teme per la propria incolumità, qualcosa di essenziale nel setting si è incrinato.
È molto importante sottolineare questo:
il fatto che lei abbia percepito paura non è una sua esagerazione, né una prova di essere “una paziente difficile”. È una reazione coerente con la sua storia, con il suo attuale stato di ipervigilanza e con ciò che è accaduto in seduta. In terapia non è il paziente che deve “reggere” l’intensità dell’intervento del terapeuta, ma è il terapeuta che ha la responsabilità di modulare il proprio intervento sulla base della struttura e della vulnerabilità della persona che ha davanti.
Il controtransfert esiste, ed è vero che può diventare uno strumento di comprensione clinica. Tuttavia, non tutto ciò che nasce dal controtransfert è automaticamente terapeutico. Quando un agito – come urlare, avvicinarsi fisicamente in modo percepito come minaccioso, impedire simbolicamente l’uscita – provoca riattivazione traumatica, blocco e paura, quel controtransfert necessita di essere elaborato dal terapeuta, non messo in atto sul paziente.
Mi colpisce molto la sua capacità di tenere insieme più livelli:
– la consapevolezza del transfert negativo
– il senso di colpa per l’interruzione
– la preoccupazione di “non essere facile”
– e allo stesso tempo il bisogno di proteggersi
Questo senso di colpa è comprensibile, ma è importante chiarire un punto: lei non deve prendersi cura della sua terapeuta, né proteggerla dal dolore di un’interruzione. La responsabilità della relazione terapeutica è sempre condivisa, ma la responsabilità del setting e della sicurezza emotiva resta del professionista.
Rispetto alla sua domanda centrale – continuare o cambiare? – più che darle una risposta netta, le propongo un criterio clinico:
in questo momento lei si sente bloccata, spaventata e non più al sicuro con questa terapeuta. In queste condizioni, la terapia difficilmente può proseguire in modo efficace, almeno senza una profonda riparazione dell’alleanza.
A volte può essere utile prevedere una seduta di chiarificazione o di chiusura, se e solo se lei si sente sufficientemente tutelata, per poter dare un senso a quanto accaduto e non vivere l’interruzione come un fallimento. Ma non è un obbligo.
Il fatto che lei stia già cercando alternative non è una fuga: è un atto di cura verso se stessa, soprattutto in una fase di grande fragilità fisica ed emotiva come quella che sta attraversando in vista dell’intervento chirurgico.
In conclusione, vorrei lasciarle un messaggio chiaro e fermo:
lei ha il diritto di scegliere un percorso terapeutico in cui si senta ascoltata, rispettata e al sicuro. Cambiare terapeuta non cancella il lavoro fatto in sei anni, né la rende incoerente o ingrata. A volte, proprio grazie a un’esperienza dolorosa, diventa possibile fare un passo più aderente ai propri bisogni profondi.
Se lo desidera, un nuovo percorso potrebbe anche aiutarla a rileggere questa esperienza non come un fallimento, ma come un passaggio evolutivo importante nella sua storia di cura.
Resto a disposizione per eventuali approfondimenti.
Un caro saluto,
Dott.ssa Caterina Lo Bianco – Psicologa clinica, Psicologa ad orientamento Sistemico-Relazionale
Gentile paziente,quello che racconta merita molta attenzione perché riguarda un aspetto centrale di qualsiasi percorso terapeutico, ovvero il senso di sicurezza. Al di là delle cornici teoriche come transfert e controtransfert, quando in seduta una persona si sente spaventata, invasa o non al sicuro, qualcosa di fondamentale si è rotto in quel momento.
È importante chiarire un punto. Il controtransfert è un fenomeno reale e noto, ma non giustifica comportamenti che oltrepassano il confine della tutela del paziente. Urlare, avvicinarsi fisicamente in modo minaccioso, impedire a una persona di andare via quando è spaventata non sono interventi terapeutici, soprattutto sapendo che le urla per lei sono un trigger legato alla sua storia familiare. Questo non è scuotere dal torpore, è riattivare un’esperienza traumatica.
Il fatto che lei abbia avuto paura non va minimizzato né razionalizzato a posteriori. Il corpo ha reagito prima delle parole e questo è un dato clinico molto importante. In terapia non si lavora contro il sistema di protezione del paziente, ma insieme ad esso. Se oggi sente un blocco, non è resistenza, è una risposta di difesa.
Il senso di colpa che prova verso la terapeuta è comprensibile e spesso nasce proprio nelle relazioni in cui ci si sente responsabili del benessere dell’altro, anche quando l’altro ha superato un limite. Ma la terapia non è un luogo in cui il paziente deve prendersi cura del terapeuta o giustificarne le reazioni. La priorità resta sempre la sua sicurezza emotiva e psicologica.
Il fatto che lei si definisca una paziente difficile, diffidente o che fa perdere la pazienza è un’altra cosa su cui fare attenzione. Queste etichette spesso si formano quando, nella storia personale, non c’è stato spazio per essere accolti senza essere corretti, contenuti o sopportati. Un terapeuta deve saper reggere anche la diffidenza, soprattutto con una storia di traumi e con una fase di ipervigilanza legata a un intervento imminente.
In questo momento, più che chiedersi se è giusto o sbagliato fare drop out, forse la domanda più onesta è se lei oggi riesce ancora a sentire quello spazio come un luogo sicuro. Se la risposta è no, cambiare terapeuta non è una fuga ma una forma di tutela. Non cancella il lavoro fatto in sei anni e non è un fallimento.
Se in futuro sentirà il bisogno di elaborare anche questa rottura, potrà farlo con un altro professionista, magari proprio partendo da ciò che è successo. Ora è legittimo fermarsi, proteggersi e scegliere ciò che le permette di stare meno in allerta. In terapia non si resta per dovere o per colpa, ma perché ci si sente sufficientemente al sicuro per continuare.
Un caro saluto
Dott.ssa A.Mustatea
È importante chiarire un punto. Il controtransfert è un fenomeno reale e noto, ma non giustifica comportamenti che oltrepassano il confine della tutela del paziente. Urlare, avvicinarsi fisicamente in modo minaccioso, impedire a una persona di andare via quando è spaventata non sono interventi terapeutici, soprattutto sapendo che le urla per lei sono un trigger legato alla sua storia familiare. Questo non è scuotere dal torpore, è riattivare un’esperienza traumatica.
Il fatto che lei abbia avuto paura non va minimizzato né razionalizzato a posteriori. Il corpo ha reagito prima delle parole e questo è un dato clinico molto importante. In terapia non si lavora contro il sistema di protezione del paziente, ma insieme ad esso. Se oggi sente un blocco, non è resistenza, è una risposta di difesa.
Il senso di colpa che prova verso la terapeuta è comprensibile e spesso nasce proprio nelle relazioni in cui ci si sente responsabili del benessere dell’altro, anche quando l’altro ha superato un limite. Ma la terapia non è un luogo in cui il paziente deve prendersi cura del terapeuta o giustificarne le reazioni. La priorità resta sempre la sua sicurezza emotiva e psicologica.
Il fatto che lei si definisca una paziente difficile, diffidente o che fa perdere la pazienza è un’altra cosa su cui fare attenzione. Queste etichette spesso si formano quando, nella storia personale, non c’è stato spazio per essere accolti senza essere corretti, contenuti o sopportati. Un terapeuta deve saper reggere anche la diffidenza, soprattutto con una storia di traumi e con una fase di ipervigilanza legata a un intervento imminente.
In questo momento, più che chiedersi se è giusto o sbagliato fare drop out, forse la domanda più onesta è se lei oggi riesce ancora a sentire quello spazio come un luogo sicuro. Se la risposta è no, cambiare terapeuta non è una fuga ma una forma di tutela. Non cancella il lavoro fatto in sei anni e non è un fallimento.
Se in futuro sentirà il bisogno di elaborare anche questa rottura, potrà farlo con un altro professionista, magari proprio partendo da ciò che è successo. Ora è legittimo fermarsi, proteggersi e scegliere ciò che le permette di stare meno in allerta. In terapia non si resta per dovere o per colpa, ma perché ci si sente sufficientemente al sicuro per continuare.
Un caro saluto
Dott.ssa A.Mustatea
Mi dispiace per l'accaduto.
Il contro-transtert è normale in terapia e permette di capire quelle dinamiche che si ripetono nella vita del paziente (ad esempio "non mi reputo facile"/"gli altri mi aggrediscono"), ma è compito del terapeuta coglierlo e dargli un significato, non certo agirlo, specialmente quando si tratta di agiti esplosivi.
E' anche vero che si tratta di un percorso di sei anni, per cui una relazione (sana o meno che sia) immagino che si sia instaurata ed abbia una sua importanza.
Rispetto a ciò che ha raccontato, il drop-out sarebbe comprensibile, ma sarebbe arrogante da parte mia dirle cosa è più utile fare dato che la vostra relazione è estremamente personale ed io sono un estraneo.
Mi limiterò a darle questo consiglio: qualunque sarà la sua scelta, si conceda almeno un ultimo incontro con la sua terapeuta, eventualmente dicendovi ad alta voce che quello sarà l'ultimo. Così facendo avrete modo di parlarne e l'interruzione, se ci sarà, non sarà improvvisa ma avvenuta con un saluto consapevole e reciproco, in onore anche dei sei anni trascorsi insieme.
In ogni caso, in bocca al lupo
Il contro-transtert è normale in terapia e permette di capire quelle dinamiche che si ripetono nella vita del paziente (ad esempio "non mi reputo facile"/"gli altri mi aggrediscono"), ma è compito del terapeuta coglierlo e dargli un significato, non certo agirlo, specialmente quando si tratta di agiti esplosivi.
E' anche vero che si tratta di un percorso di sei anni, per cui una relazione (sana o meno che sia) immagino che si sia instaurata ed abbia una sua importanza.
Rispetto a ciò che ha raccontato, il drop-out sarebbe comprensibile, ma sarebbe arrogante da parte mia dirle cosa è più utile fare dato che la vostra relazione è estremamente personale ed io sono un estraneo.
Mi limiterò a darle questo consiglio: qualunque sarà la sua scelta, si conceda almeno un ultimo incontro con la sua terapeuta, eventualmente dicendovi ad alta voce che quello sarà l'ultimo. Così facendo avrete modo di parlarne e l'interruzione, se ci sarà, non sarà improvvisa ma avvenuta con un saluto consapevole e reciproco, in onore anche dei sei anni trascorsi insieme.
In ogni caso, in bocca al lupo
Buongiorno,
se se la sentiva ha fatto bene ha chiedere alla nutrizionista altri riferimenti.
Spesso si consiglia un'ultima seduta per chiudere il rapporto. Tuttavia, se sente un blocco nei confronti della sua terapeuta,non è obbligata a farlo di persona. Può anche decidere di elaborare questa rottura con un nuovo terapeuta. Quello che si è verificato è come diceva lei stessa un controtranfert, che solitamente va tenuto sotto controllo, reagire emotivamente al paziente non è funzionale alla relazione, non conosco bene l'approccio psicoanalitico usato dalla sua psicologa, ma la base della relazione è sicuramente un'allenaza teraputicache non deve macare per la guarigiuone. Dopo 6 anni penso che possa valutare i benifici della sua terapia e decidere se restqare o no. Definirsi una paziente diffcile denota una valutazione su se stessa che le fa onore , in ogni caso segua i suoi sentimenti.
Saluti
La dott.ssa Pazzola Annalisa
se se la sentiva ha fatto bene ha chiedere alla nutrizionista altri riferimenti.
Spesso si consiglia un'ultima seduta per chiudere il rapporto. Tuttavia, se sente un blocco nei confronti della sua terapeuta,non è obbligata a farlo di persona. Può anche decidere di elaborare questa rottura con un nuovo terapeuta. Quello che si è verificato è come diceva lei stessa un controtranfert, che solitamente va tenuto sotto controllo, reagire emotivamente al paziente non è funzionale alla relazione, non conosco bene l'approccio psicoanalitico usato dalla sua psicologa, ma la base della relazione è sicuramente un'allenaza teraputicache non deve macare per la guarigiuone. Dopo 6 anni penso che possa valutare i benifici della sua terapia e decidere se restqare o no. Definirsi una paziente diffcile denota una valutazione su se stessa che le fa onore , in ogni caso segua i suoi sentimenti.
Saluti
La dott.ssa Pazzola Annalisa

Buongiorno, le consiglio di fare un altro incontro in cui parlare a cuore aperto con la sua terapeuta e di dare a voce a quello che lei ha sentito in modo da poter elaborare insieme e metabolizzare dentro di sé la scelta più giusta per lei. Solo lei può sapere cosa è meglio per sé, ascolti il suo corpo e le sensazioni che le dà nel momento presente in cui affronterà la situazione.
Spero di esserle stata di aiuto
Spero di esserle stata di aiuto
La ringrazio sinceramente per la sua condivisione, che appare molto sentita e carica di vissuti complessi. È comprensibile che quanto accaduto in seduta l’abbia scossa e che ora si trovi in uno stato di confusione.
Il setting terapeutico deve essere, prima di tutto, uno spazio sicuro, fondato sull' alleanza terapeutica. Al di là delle cornici teoriche (transfert, controtransfert, tecniche “attive”), quando in seduta una persona si sente minacciata, spaventata o non al sicuro, qualcosa di essenziale nel processo terapeutico si è incrinato.
L’alleanza terapeutica è uno dei principali fattori di efficacia della terapia. Se viene meno, o se si rompe in modo significativo, il percorso rischia inevitabilmente di diventare faticoso, rallentato o poco utile. In questi casi, la domanda da porsi non è “di chi è la colpa”, ma che cosa può aiutarla davvero a stare meglio, oggi?
Si può lavorare su rotture dell’alleanza, ma questo è possibile solo se la persona si sente nuovamente al sicuro e se c’è una reale possibilità di riparazione. Dal suo racconto emerge invece un **blocco profondo**, comprensibile anche alla luce della sua storia traumatica, della sensibilità alle urla e dello stato di ipervigilanza legato alla situazione medica attuale.
È importante anche sottolineare che **non esiste il concetto di “paziente difficile” in senso colpevolizzante: esistono storie complesse, difese sviluppate per sopravvivere, e bisogni di sicurezza più marcati. Inoltre, non sempre c’è un buon “match” tra terapeuta e paziente. Questo non è raro, non è patologico e non è un fallimento: significa semplicemente che non tutti i professionisti sono adatti a tutti, e trovare il proprio posto è parte del processo di cura.
Il senso di colpa che prova è comprensibile, ma va ridimensionato: prendersi cura di sé e dei propri limiti non equivale a mancare di rispetto all’altro. Interrompere una terapia quando non ci si sente più al sicuro è una scelta legittima.
In questo momento, la cosa più importante è scegliere ciò che può sostenerla e farla sentire tutelata, soprattutto in una fase di vulnerabilità fisica ed emotiva come quella che sta attraversando. Cercare un altro terapeuta non significa buttare via il lavoro fatto, ma proseguire il suo percorso in una direzione più rispettosa dei suoi bisogni attuali.
Rimango a disposizione, se lo desidera, per aiutarla a orientarsi nella scelta di un nuovo percorso o per approfondire ulteriormente questi vissuti.
Il setting terapeutico deve essere, prima di tutto, uno spazio sicuro, fondato sull' alleanza terapeutica. Al di là delle cornici teoriche (transfert, controtransfert, tecniche “attive”), quando in seduta una persona si sente minacciata, spaventata o non al sicuro, qualcosa di essenziale nel processo terapeutico si è incrinato.
L’alleanza terapeutica è uno dei principali fattori di efficacia della terapia. Se viene meno, o se si rompe in modo significativo, il percorso rischia inevitabilmente di diventare faticoso, rallentato o poco utile. In questi casi, la domanda da porsi non è “di chi è la colpa”, ma che cosa può aiutarla davvero a stare meglio, oggi?
Si può lavorare su rotture dell’alleanza, ma questo è possibile solo se la persona si sente nuovamente al sicuro e se c’è una reale possibilità di riparazione. Dal suo racconto emerge invece un **blocco profondo**, comprensibile anche alla luce della sua storia traumatica, della sensibilità alle urla e dello stato di ipervigilanza legato alla situazione medica attuale.
È importante anche sottolineare che **non esiste il concetto di “paziente difficile” in senso colpevolizzante: esistono storie complesse, difese sviluppate per sopravvivere, e bisogni di sicurezza più marcati. Inoltre, non sempre c’è un buon “match” tra terapeuta e paziente. Questo non è raro, non è patologico e non è un fallimento: significa semplicemente che non tutti i professionisti sono adatti a tutti, e trovare il proprio posto è parte del processo di cura.
Il senso di colpa che prova è comprensibile, ma va ridimensionato: prendersi cura di sé e dei propri limiti non equivale a mancare di rispetto all’altro. Interrompere una terapia quando non ci si sente più al sicuro è una scelta legittima.
In questo momento, la cosa più importante è scegliere ciò che può sostenerla e farla sentire tutelata, soprattutto in una fase di vulnerabilità fisica ed emotiva come quella che sta attraversando. Cercare un altro terapeuta non significa buttare via il lavoro fatto, ma proseguire il suo percorso in una direzione più rispettosa dei suoi bisogni attuali.
Rimango a disposizione, se lo desidera, per aiutarla a orientarsi nella scelta di un nuovo percorso o per approfondire ulteriormente questi vissuti.
Buonasera, la situazione è complessa e da quel che leggo è sicuramente stata un'esperienza molto pesante per lei in qualità di paziente. Quali che siano le ragioni ritengo che urlare, per come ha raccontato lei, non siano in alcun modo "terapeutico", tuttavia dato il rapporto di lunga data con la sua terapeuta potrebbe anche prendere in considerazione l'idea di fare un'ultima seduta, in cui spiega le ragioni che l'hanno portata a prendere questa decisione. In questo modo potrebbe aiutare anche lei, sentendo di aver concluso il percorso e non di averlo abbandonato all'improvviso.

Buongiorno,
la ringrazio per aver condiviso con tanta chiarezza e profondità un’esperienza che appare per lei molto intensa e dolorosa. Da ciò che descrive, l’episodio vissuto in seduta ha generato paura, un senso di perdita di sicurezza e un blocco emotivo comprensibile, soprattutto considerando la sua storia relazionale, i traumi pregressi e il momento di particolare vulnerabilità fisica e psicologica che sta attraversando.
Indipendentemente dalle letture teoriche di transfert o controtransfert, un elemento centrale in ogni percorso terapeutico è che la persona possa sentirsi al sicuro, rispettata e libera di esprimere ciò che prova. Quando questo viene meno, è importante fermarsi e interrogarsi su quanto accaduto e su come proseguire, senza colpevolizzarsi.
Può essere utile, se e quando si sentirà pronta, valutare se esistono le condizioni per un chiarimento autentico e riparativo all’interno della relazione terapeutica; allo stesso tempo, è altrettanto legittimo considerare la possibilità di un cambiamento, qualora il blocco e la paura rendessero difficile continuare il lavoro in modo sereno. Interrompere o modificare un percorso non equivale a “fallire”, ma può rappresentare una scelta di tutela e di cura di sé.
La invito a dare ascolto ai suoi vissuti, cercando un confronto che la aiuti a orientarsi con calma e rispetto per se stessa, senza forzature.
Un caro saluto,
Dott. Fabio Mallardo
Psicologo-Psicoterapeuta
Ricevo anche on-line
la ringrazio per aver condiviso con tanta chiarezza e profondità un’esperienza che appare per lei molto intensa e dolorosa. Da ciò che descrive, l’episodio vissuto in seduta ha generato paura, un senso di perdita di sicurezza e un blocco emotivo comprensibile, soprattutto considerando la sua storia relazionale, i traumi pregressi e il momento di particolare vulnerabilità fisica e psicologica che sta attraversando.
Indipendentemente dalle letture teoriche di transfert o controtransfert, un elemento centrale in ogni percorso terapeutico è che la persona possa sentirsi al sicuro, rispettata e libera di esprimere ciò che prova. Quando questo viene meno, è importante fermarsi e interrogarsi su quanto accaduto e su come proseguire, senza colpevolizzarsi.
Può essere utile, se e quando si sentirà pronta, valutare se esistono le condizioni per un chiarimento autentico e riparativo all’interno della relazione terapeutica; allo stesso tempo, è altrettanto legittimo considerare la possibilità di un cambiamento, qualora il blocco e la paura rendessero difficile continuare il lavoro in modo sereno. Interrompere o modificare un percorso non equivale a “fallire”, ma può rappresentare una scelta di tutela e di cura di sé.
La invito a dare ascolto ai suoi vissuti, cercando un confronto che la aiuti a orientarsi con calma e rispetto per se stessa, senza forzature.
Un caro saluto,
Dott. Fabio Mallardo
Psicologo-Psicoterapeuta
Ricevo anche on-line
Stai ancora cercando una risposta? Poni un'altra domanda
Tutti i contenuti pubblicati su MioDottore.it, specialmente domande e risposte, sono di carattere informativo e in nessun caso devono essere considerati un sostituto di una visita specialistica.