Buongiorno! Mi chiamo Francesca, ho quasi 30 anni e non so più che strada percorrere, mi sento paral
16
risposte
Buongiorno! Mi chiamo Francesca, ho quasi 30 anni e non so più che strada percorrere, mi sento paralizzata e confusa. Sono sempre stata una bambina e poi una ragazza fuori dagli schemi, sempre in direzione contraria, che si metteva contro tutto e tutti se vedeva un'ingiustizia, che alle elementari preferiva leggere di nascosto anziché ascoltare le lezioni, che voleva fare l'artista di strada (ho tentato la strada della danza ma non ce l'ho fatta).
Da quando ho conseguito il diploma la mia vita è stata un'alternanza di depressione, apatia e sbalzi d'umore. Ho fatto vari tentativi per prendere in mano la mia vita ma sono tutti andati male. Ho provato a fare l'università più volte ma non mi interessava veramente, ho sempre amato studiare a modo mio, e poi ero incostante. Tutti i lavori che ho svolto sono durati un anno circa perché poi mi veniva l'esaurimento (non ho mai saputo indossare la maschera, sono un'anticonsumista che sta fuori dal mondo, come faccio a vendere qualcosa in cui non credo?).
Adesso sono inoccupata e non so dove sbattere la testa. Voglio un lavoro ma nello stesso tempo non voglio essere schiava di una società che mira al consumo e al profitto. Nonostante psicofarmaci (che sento poco) e psicoterapia, tentativi di realizzare sogni che non sono mai stati realizzati, sono a un punto morto. Sono apatica e/o depressa praticamente da quando mi sono diplomata. Non riesco ad avere amici da quando mi sono diplomata, non riesco ad appassionarmi in qualcosa che non sia la lettura (leggo 2 libri a settimana circa, anche di quelli tosti). Sto buttando la mia vita ma non so come rimediare perché mi manca sentire qualche emozione all'interno del mio cuore, mi manca un sogno. Vorrei "volere" ma non so come fare. Vorrei avere un sogno. L'unica cosa che mi permette di sopravvivere sono i libri, se no l'avrei già fatta finita. E da un paio di giorni ho iniziato a studiare l'arabo, così per passione non per farne un lavoro. Non so che fare, se inizio a lavorare poi finisce che litigo con il mio capo e piango disperata ogni volta che devo andare a lavoro. Se non lavoro mi dispero pure.
Faccio psicoterapia da ormai 10 anni , ho cambiato psicoterapeuta da circa 4 mesi, ma il problema è sempre uno: l'apatia. Per quanto riguarda i farmaci, prendo da 1 anno circa venlafaxina e edronax ( devo dire che questa combinazione è quella che ho sentito di più tra quelle che ho provato negli ultimi 10 anni). Scusate gli errori di grammatica, ma sono veramente a pezzi. Ho fatto la cameriera, la receptionist, la doposcuolista, la tutor linguistica, ma ho sempre finito per odiare ogni lavoro. Ufficialmente ho un QI di quasi 130 e memorizzo tutto subito, ma non so tenermi un lavoro e nemmeno farmi un amico. Mi sento persa. Come si fa a combattere con l'apatia? Io ce la metto tutta, ma se poi mi manca la voglia come faccio ad andare avanti? Mi hanno dato risperdal, maveral, zoloft, aripripazolo, topimarato, litio, eppure sembra che niente mi attivi veramente. Sono senza soldi tra l'altro i miei stanno messi pure male economicamente e mi vergogno a vivere ancora da loro, ma anche se lavoro non trovo niente che sia più di 1000€ al mese per 40/45 ore di lavoro. Dovrò convivere per sempre con questa apatia? L'unica emozione che provo, ogni tanto, è la rabbia contro il sistema, contro la disinformazione mediatica, contro l'ipocrisia. Vi ringrazio.
Da quando ho conseguito il diploma la mia vita è stata un'alternanza di depressione, apatia e sbalzi d'umore. Ho fatto vari tentativi per prendere in mano la mia vita ma sono tutti andati male. Ho provato a fare l'università più volte ma non mi interessava veramente, ho sempre amato studiare a modo mio, e poi ero incostante. Tutti i lavori che ho svolto sono durati un anno circa perché poi mi veniva l'esaurimento (non ho mai saputo indossare la maschera, sono un'anticonsumista che sta fuori dal mondo, come faccio a vendere qualcosa in cui non credo?).
Adesso sono inoccupata e non so dove sbattere la testa. Voglio un lavoro ma nello stesso tempo non voglio essere schiava di una società che mira al consumo e al profitto. Nonostante psicofarmaci (che sento poco) e psicoterapia, tentativi di realizzare sogni che non sono mai stati realizzati, sono a un punto morto. Sono apatica e/o depressa praticamente da quando mi sono diplomata. Non riesco ad avere amici da quando mi sono diplomata, non riesco ad appassionarmi in qualcosa che non sia la lettura (leggo 2 libri a settimana circa, anche di quelli tosti). Sto buttando la mia vita ma non so come rimediare perché mi manca sentire qualche emozione all'interno del mio cuore, mi manca un sogno. Vorrei "volere" ma non so come fare. Vorrei avere un sogno. L'unica cosa che mi permette di sopravvivere sono i libri, se no l'avrei già fatta finita. E da un paio di giorni ho iniziato a studiare l'arabo, così per passione non per farne un lavoro. Non so che fare, se inizio a lavorare poi finisce che litigo con il mio capo e piango disperata ogni volta che devo andare a lavoro. Se non lavoro mi dispero pure.
Faccio psicoterapia da ormai 10 anni , ho cambiato psicoterapeuta da circa 4 mesi, ma il problema è sempre uno: l'apatia. Per quanto riguarda i farmaci, prendo da 1 anno circa venlafaxina e edronax ( devo dire che questa combinazione è quella che ho sentito di più tra quelle che ho provato negli ultimi 10 anni). Scusate gli errori di grammatica, ma sono veramente a pezzi. Ho fatto la cameriera, la receptionist, la doposcuolista, la tutor linguistica, ma ho sempre finito per odiare ogni lavoro. Ufficialmente ho un QI di quasi 130 e memorizzo tutto subito, ma non so tenermi un lavoro e nemmeno farmi un amico. Mi sento persa. Come si fa a combattere con l'apatia? Io ce la metto tutta, ma se poi mi manca la voglia come faccio ad andare avanti? Mi hanno dato risperdal, maveral, zoloft, aripripazolo, topimarato, litio, eppure sembra che niente mi attivi veramente. Sono senza soldi tra l'altro i miei stanno messi pure male economicamente e mi vergogno a vivere ancora da loro, ma anche se lavoro non trovo niente che sia più di 1000€ al mese per 40/45 ore di lavoro. Dovrò convivere per sempre con questa apatia? L'unica emozione che provo, ogni tanto, è la rabbia contro il sistema, contro la disinformazione mediatica, contro l'ipocrisia. Vi ringrazio.
Buongiorno Francesca,
dal suo racconto emerge una sofferenza profonda, persistente nel tempo, che non può essere ridotta a una semplice “mancanza di voglia” o a un problema di adattamento lavorativo. L’apatia che descrive appare come un nucleo centrale del suo funzionamento emotivo da molti anni, intrecciata a vissuti depressivi, a una forte sensibilità etica e a un senso di estraneità rispetto ai modelli sociali e lavorativi dominanti.
È importante chiarire un punto: l’apatia non si combatte con la forza di volontà. Non è una scelta, né un difetto di carattere. Spesso è un sintomo complesso, che può essere legato a forme depressive croniche, a quadri di demoralizzazione profonda, a un conflitto identitario irrisolto o a una lunga storia di frustrazione dei propri bisogni autentici. In questi casi “fare di più” o “sforzarsi di volere” rischia solo di aumentare il senso di fallimento.
Nel suo racconto colpiscono alcuni elementi che meritano un lavoro clinico mirato: la sensazione di essere fuori posto nel mondo, la difficoltà a tollerare contesti percepiti come incoerenti con i suoi valori, l’alternanza tra idealismo e crollo, la rabbia come unica emozione ancora vitale, e il fatto che la lettura e lo studio per passione restino spazi di investimento emotivo. Questo indica che la capacità di interessarsi, pensare e sentire non è assente, ma confinata in luoghi che non vengono riconosciuti come “legittimi” o spendibili.
Dopo molti anni di terapia e diversi tentativi farmacologici, può essere utile chiedersi non “cosa non funziona in lei”, ma se il lavoro terapeutico stia affrontando in modo sufficientemente profondo il tema del senso, dell’identità e del rapporto tra i suoi valori e la realtà esterna. A volte è necessario rivedere l’inquadramento diagnostico, gli obiettivi della terapia e il modo in cui viene trattata l’apatia, non come sintomo da eliminare, ma come segnale di un blocco più ampio.
Il tema del lavoro, così come lo descrive, sembra essere vissuto come un luogo di violenza interna, più che come una semplice fonte di reddito. In questi casi può essere utile pensare a percorsi graduali, parziali, protetti, o a forme di impegno che non coincidano subito con il lavoro standard a tempo pieno, evitando di forzare un adattamento che oggi appare insostenibile.
La domanda che pone, “dovrò convivere per sempre con questa apatia?”, non ha una risposta semplice, ma una cosa è importante dirla chiaramente: il fatto che lei continui a interrogarsi, a leggere, a studiare, a cercare, indica che non è spenta, anche se si sente così. Il lavoro clinico dovrebbe partire proprio da lì, senza colpevolizzarla né spingerla a diventare qualcosa che oggi non riesce a essere.
Le suggerisco di portare questo stesso messaggio, magari anche stampato, al suo attuale terapeuta, per aprire un confronto esplicito su come state lavorando sull’apatia e su quali ipotesi cliniche guidano il percorso. In alcuni casi può essere utile anche una valutazione specialistica integrata, che tenga insieme aspetti dell’umore, della personalità e del funzionamento esistenziale.
La sua sofferenza merita ascolto e rispetto. Non è un fallimento personale. È una condizione che può essere compresa e, nel tempo, trasformata.
dal suo racconto emerge una sofferenza profonda, persistente nel tempo, che non può essere ridotta a una semplice “mancanza di voglia” o a un problema di adattamento lavorativo. L’apatia che descrive appare come un nucleo centrale del suo funzionamento emotivo da molti anni, intrecciata a vissuti depressivi, a una forte sensibilità etica e a un senso di estraneità rispetto ai modelli sociali e lavorativi dominanti.
È importante chiarire un punto: l’apatia non si combatte con la forza di volontà. Non è una scelta, né un difetto di carattere. Spesso è un sintomo complesso, che può essere legato a forme depressive croniche, a quadri di demoralizzazione profonda, a un conflitto identitario irrisolto o a una lunga storia di frustrazione dei propri bisogni autentici. In questi casi “fare di più” o “sforzarsi di volere” rischia solo di aumentare il senso di fallimento.
Nel suo racconto colpiscono alcuni elementi che meritano un lavoro clinico mirato: la sensazione di essere fuori posto nel mondo, la difficoltà a tollerare contesti percepiti come incoerenti con i suoi valori, l’alternanza tra idealismo e crollo, la rabbia come unica emozione ancora vitale, e il fatto che la lettura e lo studio per passione restino spazi di investimento emotivo. Questo indica che la capacità di interessarsi, pensare e sentire non è assente, ma confinata in luoghi che non vengono riconosciuti come “legittimi” o spendibili.
Dopo molti anni di terapia e diversi tentativi farmacologici, può essere utile chiedersi non “cosa non funziona in lei”, ma se il lavoro terapeutico stia affrontando in modo sufficientemente profondo il tema del senso, dell’identità e del rapporto tra i suoi valori e la realtà esterna. A volte è necessario rivedere l’inquadramento diagnostico, gli obiettivi della terapia e il modo in cui viene trattata l’apatia, non come sintomo da eliminare, ma come segnale di un blocco più ampio.
Il tema del lavoro, così come lo descrive, sembra essere vissuto come un luogo di violenza interna, più che come una semplice fonte di reddito. In questi casi può essere utile pensare a percorsi graduali, parziali, protetti, o a forme di impegno che non coincidano subito con il lavoro standard a tempo pieno, evitando di forzare un adattamento che oggi appare insostenibile.
La domanda che pone, “dovrò convivere per sempre con questa apatia?”, non ha una risposta semplice, ma una cosa è importante dirla chiaramente: il fatto che lei continui a interrogarsi, a leggere, a studiare, a cercare, indica che non è spenta, anche se si sente così. Il lavoro clinico dovrebbe partire proprio da lì, senza colpevolizzarla né spingerla a diventare qualcosa che oggi non riesce a essere.
Le suggerisco di portare questo stesso messaggio, magari anche stampato, al suo attuale terapeuta, per aprire un confronto esplicito su come state lavorando sull’apatia e su quali ipotesi cliniche guidano il percorso. In alcuni casi può essere utile anche una valutazione specialistica integrata, che tenga insieme aspetti dell’umore, della personalità e del funzionamento esistenziale.
La sua sofferenza merita ascolto e rispetto. Non è un fallimento personale. È una condizione che può essere compresa e, nel tempo, trasformata.
Risolvi i tuoi dubbi grazie alla consulenza online
Se hai bisogno del consiglio di uno specialista, prenota una consulenza online. Otterrai risposte senza muoverti da casa.
Mostra risultati Come funziona?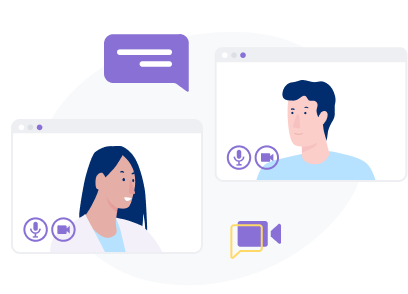
E' davvero un peccato che una persona con un QI così importante non dedichi la sua vita alla ricerca. Che studi ha fatto ? Non si è mai proposta per una borsa di studio ? A parte le lingue (ottimo l'apprendimento dell'arabo, le sarà sicuramente utile) che altri interessi le piacerebbe approfondire? Si dedichi a ciò che la incuriosisce, poi ci sono ambienti in cui si creano amicizie fondate sui comuni scopi. Non si scoraggi così, faccia fruttare il dono che madre natura le ha regalato.

Gentile Francesca,
dal suo messaggio emerge una sofferenza profonda che nasce, più che da mancanza di capacità o di intelligenza, da un conflitto molto forte tra ciò che sente di essere e il mondo in cui fatica a trovare posto. Più che priva di risorse sembra una persona sensibile, critica, con un’intensa vita interiore, che da molti anni vive una condizione di blocco emotivo e di stanchezza esistenziale.
L’apatia spesso è il risultato di una depressione di lunga durata, in cui l’energia vitale e il desiderio si spengono progressivamente, soprattutto quando per anni si è cercato di adattarsi a contesti percepiti come incoerenti con i propri valori. Il fatto che lei reagisca con rabbia verso il “sistema” non è casuale: quella rabbia è probabilmente una delle poche emozioni ancora vive e può essere un segnale da ascoltare, non da reprimere.
È significativo che i libri e lo studio siano gli unici ambiti in cui sente ancora un minimo di movimento interno. Questo dice che la capacità di interesse non è persa ma non riesce ad agganciarsi a ciò che viene vissuto come obbligo, maschera, compromesso identitario. Non tutte le persone riescono a funzionare nei lavori standardizzati, soprattutto se hanno un forte senso etico e un bisogno di autenticità.
Dopo tanti anni di terapia e diversi tentativi farmacologici, forse la domanda oggi non è “come farmi venire voglia” ma che tipo di vita è compatibile con il mio funzionamento. A volte il lavoro terapeutico deve spostarsi dal “correggere l’apatia” al comprendere che ruolo ha avuto nella sua storia: come difesa, come ritiro, come modo per non tradire se stessa.
Non è detto che debba “attivarsi” come fanno gli altri. Potrebbe essere più utile pensare a piccoli spazi di senso, non immediatamente produttivi, ma sostenibili: attività culturali, percorsi formativi non finalizzati subito al lavoro, contesti meno gerarchici e meno orientati alla performance. Anche un lavoro part-time o atipico, se coerente con i suoi valori, può essere più tollerabile di un impiego vissuto come alienante.
Infine, se in terapia il tema centrale resta sempre l’apatia, può essere utile esplicitarlo apertamente con il terapeuta: non come sintomo da eliminare ma come nodo esistenziale da comprendere insieme. Lei non è “rotta” e da anni sta cercando un posto possibile per sé.
Un caro saluto e un augurio sincero di poter trovare, con gradualità, una direzione che non la costringa a rinnegarsi.
Gabriele
dal suo messaggio emerge una sofferenza profonda che nasce, più che da mancanza di capacità o di intelligenza, da un conflitto molto forte tra ciò che sente di essere e il mondo in cui fatica a trovare posto. Più che priva di risorse sembra una persona sensibile, critica, con un’intensa vita interiore, che da molti anni vive una condizione di blocco emotivo e di stanchezza esistenziale.
L’apatia spesso è il risultato di una depressione di lunga durata, in cui l’energia vitale e il desiderio si spengono progressivamente, soprattutto quando per anni si è cercato di adattarsi a contesti percepiti come incoerenti con i propri valori. Il fatto che lei reagisca con rabbia verso il “sistema” non è casuale: quella rabbia è probabilmente una delle poche emozioni ancora vive e può essere un segnale da ascoltare, non da reprimere.
È significativo che i libri e lo studio siano gli unici ambiti in cui sente ancora un minimo di movimento interno. Questo dice che la capacità di interesse non è persa ma non riesce ad agganciarsi a ciò che viene vissuto come obbligo, maschera, compromesso identitario. Non tutte le persone riescono a funzionare nei lavori standardizzati, soprattutto se hanno un forte senso etico e un bisogno di autenticità.
Dopo tanti anni di terapia e diversi tentativi farmacologici, forse la domanda oggi non è “come farmi venire voglia” ma che tipo di vita è compatibile con il mio funzionamento. A volte il lavoro terapeutico deve spostarsi dal “correggere l’apatia” al comprendere che ruolo ha avuto nella sua storia: come difesa, come ritiro, come modo per non tradire se stessa.
Non è detto che debba “attivarsi” come fanno gli altri. Potrebbe essere più utile pensare a piccoli spazi di senso, non immediatamente produttivi, ma sostenibili: attività culturali, percorsi formativi non finalizzati subito al lavoro, contesti meno gerarchici e meno orientati alla performance. Anche un lavoro part-time o atipico, se coerente con i suoi valori, può essere più tollerabile di un impiego vissuto come alienante.
Infine, se in terapia il tema centrale resta sempre l’apatia, può essere utile esplicitarlo apertamente con il terapeuta: non come sintomo da eliminare ma come nodo esistenziale da comprendere insieme. Lei non è “rotta” e da anni sta cercando un posto possibile per sé.
Un caro saluto e un augurio sincero di poter trovare, con gradualità, una direzione che non la costringa a rinnegarsi.
Gabriele

Gentile Utente, che cosa Le manca? Si sente insoddisfatta? Vive in una società che non Le piace, comprende che è arrivato il momento di "volare via" da casa dei suoi genitori ma non riesce a farlo. Farmaci, psicoterapia ... eppure nulla riesce ad eliminare l'apatia. Che cosa Le manca? L'insoddisfazione che sente dentro di Lei viene proiettata all'esterno e cerchiamo qualcosa che non arriverà mai. Perché non riesce a distaccarsi dai suoi genitori? La rabbia che prova Le sta dicendo qualcosa ma sembra che Lei è "sorda" ad ascoltare il suo corpo. La invito ad approfondire le sue emozioni e a riconoscere il significato che hanno per Lei. Grazie.
Buongiorno Francesca,
ciò che racconta restituisce l’immagine di una persona molto sensibile, lucida, che da anni vive una frattura dolorosa tra il proprio mondo interno e le richieste della realtà esterna. Non appare tanto una mancanza di capacità o di risorse – che anzi sono evidenti – quanto una fatica cronica nel trovare un posto possibile per sé, che non venga vissuto come una rinuncia alla propria identità o ai propri valori.
L’apatia che descrive non sembra un semplice “vuoto” o una mancanza di volontà, ma piuttosto una forma di congelamento emotivo che si è strutturata nel tempo, probabilmente come risposta a ripetute esperienze di frustrazione, fallimento percepito e conflitto tra ciò che sente autentico e ciò che il mondo sembra richiederLe. In questo senso, l’apatia può essere letta non come un nemico da combattere con la forza, ma come un segnale di esaurimento, di una parte di sé che ha smesso di investire perché farlo è stato, troppo spesso, doloroso.
Colpisce come la lettura e lo studio “libero” (come ora l’arabo) restino per Lei spazi vitali: luoghi in cui l’interesse, la curiosità e una forma di emozione sono ancora accessibili. Questo indica che la capacità di desiderare non è scomparsa, ma sembra potersi attivare solo quando non è immediatamente legata a prestazioni, giudizi, aspettative esterne o alla necessità di “funzionare”. Il problema, quindi, potrebbe non essere l’assenza di sogni, ma il fatto che ogni sogno, quando entra nel mondo reale, venga rapidamente soffocato da pressioni interne ed esterne molto severe.
Rispetto al lavoro, il conflitto che descrive, tra il bisogno di autonomia e significato e la realtà di impieghi vissuti come alienanti, è reale e comprensibile. Tuttavia, il rischio è che questo conflitto venga interiorizzato come un difetto personale (“non so tenermi un lavoro”, “c’è qualcosa che non va in me”), alimentando ulteriormente depressione e apatia. In terapia sarebbe importante spostare lo sguardo da “cosa non funziona in me” a “che tipo di funzionamento ho sviluppato per sopravvivere, e a quale prezzo”.
Infine, il fatto che Lei dica che senza i libri “l’avrebbe già fatta finita” è un elemento molto importante, che merita attenzione e cura. Indica quanto la sofferenza sia intensa, ma anche quanto esistano ancora appigli vitali. È fondamentale che questi vissuti possano essere portati apertamente nel percorso terapeutico e condivisi anche con chi La segue sul piano psichiatrico, affinché non restino isolati o silenziati.
La domanda “dovrò convivere per sempre con questa apatia?” è comprensibile, ma forse oggi può essere riformulata in modo meno definitivo: non tanto se l’apatia sparirà, quanto se potrà essere compresa, trasformata e resa meno dominante nella Sua vita. Questo è un lavoro possibile, ma richiede tempo, profondità e uno spazio terapeutico in cui Lei possa sentirsi davvero vista.
Cordiali Saluti
Dr.ssa Jessica Ceccherini
ciò che racconta restituisce l’immagine di una persona molto sensibile, lucida, che da anni vive una frattura dolorosa tra il proprio mondo interno e le richieste della realtà esterna. Non appare tanto una mancanza di capacità o di risorse – che anzi sono evidenti – quanto una fatica cronica nel trovare un posto possibile per sé, che non venga vissuto come una rinuncia alla propria identità o ai propri valori.
L’apatia che descrive non sembra un semplice “vuoto” o una mancanza di volontà, ma piuttosto una forma di congelamento emotivo che si è strutturata nel tempo, probabilmente come risposta a ripetute esperienze di frustrazione, fallimento percepito e conflitto tra ciò che sente autentico e ciò che il mondo sembra richiederLe. In questo senso, l’apatia può essere letta non come un nemico da combattere con la forza, ma come un segnale di esaurimento, di una parte di sé che ha smesso di investire perché farlo è stato, troppo spesso, doloroso.
Colpisce come la lettura e lo studio “libero” (come ora l’arabo) restino per Lei spazi vitali: luoghi in cui l’interesse, la curiosità e una forma di emozione sono ancora accessibili. Questo indica che la capacità di desiderare non è scomparsa, ma sembra potersi attivare solo quando non è immediatamente legata a prestazioni, giudizi, aspettative esterne o alla necessità di “funzionare”. Il problema, quindi, potrebbe non essere l’assenza di sogni, ma il fatto che ogni sogno, quando entra nel mondo reale, venga rapidamente soffocato da pressioni interne ed esterne molto severe.
Rispetto al lavoro, il conflitto che descrive, tra il bisogno di autonomia e significato e la realtà di impieghi vissuti come alienanti, è reale e comprensibile. Tuttavia, il rischio è che questo conflitto venga interiorizzato come un difetto personale (“non so tenermi un lavoro”, “c’è qualcosa che non va in me”), alimentando ulteriormente depressione e apatia. In terapia sarebbe importante spostare lo sguardo da “cosa non funziona in me” a “che tipo di funzionamento ho sviluppato per sopravvivere, e a quale prezzo”.
Infine, il fatto che Lei dica che senza i libri “l’avrebbe già fatta finita” è un elemento molto importante, che merita attenzione e cura. Indica quanto la sofferenza sia intensa, ma anche quanto esistano ancora appigli vitali. È fondamentale che questi vissuti possano essere portati apertamente nel percorso terapeutico e condivisi anche con chi La segue sul piano psichiatrico, affinché non restino isolati o silenziati.
La domanda “dovrò convivere per sempre con questa apatia?” è comprensibile, ma forse oggi può essere riformulata in modo meno definitivo: non tanto se l’apatia sparirà, quanto se potrà essere compresa, trasformata e resa meno dominante nella Sua vita. Questo è un lavoro possibile, ma richiede tempo, profondità e uno spazio terapeutico in cui Lei possa sentirsi davvero vista.
Cordiali Saluti
Dr.ssa Jessica Ceccherini
Buongiorno Francesca,
grazie davvero per quello che ha scritto. Non è un messaggio qualunque: è una richiesta d’aiuto vera, nuda, senza difese. E voglio risponderle con la stessa onestà.
La prima cosa che sento leggendo le sue parole è questa: lei non è apatica perché è vuota, ma perché è stanca di vivere in un mondo che non sente suo. La sua non è l’apatia di chi “non sente nulla”, è l’apatia di chi ha sentito troppo, troppo presto, troppo a lungo, senza trovare un posto dove poter stare senza doversi snaturare.
Lei descrive una bambina e una ragazza fuori dagli schemi, profondamente sensibile all’ingiustizia, allergica alla finzione, incapace di indossare maschere. Questo tipo di funzionamento, in una società che premia l’adattamento, la performance e il consumo, logora. Non perché ci sia qualcosa che non va in lei, ma perché il contesto chiede l’opposto di ciò che lei è.
Quando dice:
“Vorrei volere, ma non so come fare”
sta dicendo una cosa centrale. La volontà non nasce dal dovere, nasce dal sentire. E quando per anni si è dovuto sopravvivere, adattarsi, fallire, ricominciare, spiegarsi, giustificarsi, il sentire si spegne per protezione. L’apatia, in molti casi, è una difesa, non un difetto.
Lei non è pigra, non è incapace, non è “sbagliata”.
È una persona molto dotata (non solo cognitivamente), che però non ha mai trovato un contenitore adatto alla sua complessità. E questo, nel tempo, porta a una forma di depressione che i farmaci da soli fanno molta fatica a smuovere, perché non è solo biochimica, è anche esistenziale, identitaria.
Mi colpisce una cosa importante:
i libri, lo studio libero, l’arabo iniziato “per passione”.
Questo dice che in lei la scintilla non è morta. È viva, ma non vuole essere usata come merce, come prestazione, come ingranaggio. Vuole spazio, senso, profondità.
Il problema non è “che lavoro fare”.
Il problema è che ogni lavoro, finora, è diventato per lei un luogo di autonegazione. E allora il corpo e la psiche si ribellano: esaurimento, pianto, rabbia, fuga. Non perché lei non sappia lavorare, ma perché pagare il prezzo di non essere se stessa è troppo alto.
Sulla domanda: “Dovrò convivere per sempre con questa apatia?”
No. Ma probabilmente dovrà cambiare il modo in cui la guarda. Non come un nemico da combattere, ma come un segnale che dice: “così non posso vivere”.
Dopo 10 anni di terapia, spesso il rischio è questo: aver capito tanto, ma sentirsi ancora fermi. In questi casi non serve “fare di più”, ma fare diversamente. Un lavoro che vada a toccare:
il senso di identità (chi sono io, al di là di cosa produco),
il rappooto con il sistema, il potere, l’autorità,
la rabbia (che è l’unica emozione che ogni tanto sente: e non è un caso),
il lutto per i sogni non realizzati, che spesso resta congelato.
Lei non ha bisogno di essere “attivata” a forza.
Ha bisogno di sentirsi legittimata a esistere per quello che è, non per quello che rende.
Capisco anche la vergogna per la dipendenza economica, il senso di fallimento, il confronto continuo con una realtà che sembra offrire solo lavori malpagati e svuotanti. Questo pesa tantissimo sull’autostima e sull’energia vitale. Non è debolezza: è logorio.
Le dico una cosa con molta chiarezza e rispetto:
il fatto che lei sia ancora qui, che legga, che studi, che scriva questo messaggio, che non abbia “fatto finita” nonostante tutto, non è poco. È una forma di resistenza. Silenziosa, solitaria, ma reale.
La strada, per lei, non è diventare “normale”.
È trovare una forma di vita più compatibile con la sua struttura profonda. Questo richiede tempo, accompagnamento giusto e, spesso, anche il permesso di smettere di chiedersi “cosa dovrei volere” e iniziare a chiedersi “cosa mi fa sentire meno morta”.
Se sente che la terapia attuale non sta andando in questa direzione, è legittimo fermarsi a riflettere, senza colpe. Non tutto ciò che dura tanto è per forza ciò che serve ora.
Lei non è persa.
È in attesa di un senso. E questo, anche se oggi fa male, è molto diverso dall’essere vuoti.
La ringrazio per aver scritto.
E spero che, almeno per un momento, si senta un po’ meno sola.
grazie davvero per quello che ha scritto. Non è un messaggio qualunque: è una richiesta d’aiuto vera, nuda, senza difese. E voglio risponderle con la stessa onestà.
La prima cosa che sento leggendo le sue parole è questa: lei non è apatica perché è vuota, ma perché è stanca di vivere in un mondo che non sente suo. La sua non è l’apatia di chi “non sente nulla”, è l’apatia di chi ha sentito troppo, troppo presto, troppo a lungo, senza trovare un posto dove poter stare senza doversi snaturare.
Lei descrive una bambina e una ragazza fuori dagli schemi, profondamente sensibile all’ingiustizia, allergica alla finzione, incapace di indossare maschere. Questo tipo di funzionamento, in una società che premia l’adattamento, la performance e il consumo, logora. Non perché ci sia qualcosa che non va in lei, ma perché il contesto chiede l’opposto di ciò che lei è.
Quando dice:
“Vorrei volere, ma non so come fare”
sta dicendo una cosa centrale. La volontà non nasce dal dovere, nasce dal sentire. E quando per anni si è dovuto sopravvivere, adattarsi, fallire, ricominciare, spiegarsi, giustificarsi, il sentire si spegne per protezione. L’apatia, in molti casi, è una difesa, non un difetto.
Lei non è pigra, non è incapace, non è “sbagliata”.
È una persona molto dotata (non solo cognitivamente), che però non ha mai trovato un contenitore adatto alla sua complessità. E questo, nel tempo, porta a una forma di depressione che i farmaci da soli fanno molta fatica a smuovere, perché non è solo biochimica, è anche esistenziale, identitaria.
Mi colpisce una cosa importante:
i libri, lo studio libero, l’arabo iniziato “per passione”.
Questo dice che in lei la scintilla non è morta. È viva, ma non vuole essere usata come merce, come prestazione, come ingranaggio. Vuole spazio, senso, profondità.
Il problema non è “che lavoro fare”.
Il problema è che ogni lavoro, finora, è diventato per lei un luogo di autonegazione. E allora il corpo e la psiche si ribellano: esaurimento, pianto, rabbia, fuga. Non perché lei non sappia lavorare, ma perché pagare il prezzo di non essere se stessa è troppo alto.
Sulla domanda: “Dovrò convivere per sempre con questa apatia?”
No. Ma probabilmente dovrà cambiare il modo in cui la guarda. Non come un nemico da combattere, ma come un segnale che dice: “così non posso vivere”.
Dopo 10 anni di terapia, spesso il rischio è questo: aver capito tanto, ma sentirsi ancora fermi. In questi casi non serve “fare di più”, ma fare diversamente. Un lavoro che vada a toccare:
il senso di identità (chi sono io, al di là di cosa produco),
il rappooto con il sistema, il potere, l’autorità,
la rabbia (che è l’unica emozione che ogni tanto sente: e non è un caso),
il lutto per i sogni non realizzati, che spesso resta congelato.
Lei non ha bisogno di essere “attivata” a forza.
Ha bisogno di sentirsi legittimata a esistere per quello che è, non per quello che rende.
Capisco anche la vergogna per la dipendenza economica, il senso di fallimento, il confronto continuo con una realtà che sembra offrire solo lavori malpagati e svuotanti. Questo pesa tantissimo sull’autostima e sull’energia vitale. Non è debolezza: è logorio.
Le dico una cosa con molta chiarezza e rispetto:
il fatto che lei sia ancora qui, che legga, che studi, che scriva questo messaggio, che non abbia “fatto finita” nonostante tutto, non è poco. È una forma di resistenza. Silenziosa, solitaria, ma reale.
La strada, per lei, non è diventare “normale”.
È trovare una forma di vita più compatibile con la sua struttura profonda. Questo richiede tempo, accompagnamento giusto e, spesso, anche il permesso di smettere di chiedersi “cosa dovrei volere” e iniziare a chiedersi “cosa mi fa sentire meno morta”.
Se sente che la terapia attuale non sta andando in questa direzione, è legittimo fermarsi a riflettere, senza colpe. Non tutto ciò che dura tanto è per forza ciò che serve ora.
Lei non è persa.
È in attesa di un senso. E questo, anche se oggi fa male, è molto diverso dall’essere vuoti.
La ringrazio per aver scritto.
E spero che, almeno per un momento, si senta un po’ meno sola.
Ciao Francesca, grazie per aver scritto con tanta onestà. Dalle sue parole si sente una grande intensità, una mente viva, critica, sensibile e allo stesso tempo una fatica profonda, che dura da molti anni.
Mi colpisce il contrasto tra chi è, una persona anticonformista, idealista, colta, appassionata di libri, capace di indignarsi per le ingiustizie, e il mondo in cui sente di doverti adattare. Forse una parte del suo dolore nasce proprio da questo scarto: il sentirsi costretta in sistemi, lavori e ruoli che non rispecchiano i suoi valori, fino ad arrivare al punto di spegnere l’energia e il desiderio.
Parla anche di apatia, ma tra le righe emergono anche emozioni molto forti: rabbia, sensibilità, frustrazione, desiderio di senso, bisogno di bellezza, fame di conoscenza. Forse non è che “non sente nulla”, ma non trova uno spazio dove "respirare".
Dice una frase molto potente: "vorrei volere.” Come se mancasse il contatto con il desiderio. Potrebbe essere interessante chiedersi, in assenza di giudizio, se l’apatia è solo un vuoto… o anche una forma di protezione dopo tante delusioni, tentativi falliti, aspettative crollate.
I libri e lo studio dell’arabo sembrano piccole luci, non “soluzioni”, ma segni di una parte viva, curiosa, desiderosa e alla ricerca di qualcosa. Forse il sogno non deve nascere come un progetto grandioso — forse può iniziare come una scintilla, non ancora utile, solo autentica.
E rispetto alla domanda "Dovrò convivere per sempre con questa apatia?", forse una riflessione possibile è: l’apatia è la mia identità o è uno stato che racconta quanto sono stata stanca, ferita, compressa? Buona ricerca. Per ulteriori chiarimenti non esiti a contattarmi, le auguro una buona giornata.
Mi colpisce il contrasto tra chi è, una persona anticonformista, idealista, colta, appassionata di libri, capace di indignarsi per le ingiustizie, e il mondo in cui sente di doverti adattare. Forse una parte del suo dolore nasce proprio da questo scarto: il sentirsi costretta in sistemi, lavori e ruoli che non rispecchiano i suoi valori, fino ad arrivare al punto di spegnere l’energia e il desiderio.
Parla anche di apatia, ma tra le righe emergono anche emozioni molto forti: rabbia, sensibilità, frustrazione, desiderio di senso, bisogno di bellezza, fame di conoscenza. Forse non è che “non sente nulla”, ma non trova uno spazio dove "respirare".
Dice una frase molto potente: "vorrei volere.” Come se mancasse il contatto con il desiderio. Potrebbe essere interessante chiedersi, in assenza di giudizio, se l’apatia è solo un vuoto… o anche una forma di protezione dopo tante delusioni, tentativi falliti, aspettative crollate.
I libri e lo studio dell’arabo sembrano piccole luci, non “soluzioni”, ma segni di una parte viva, curiosa, desiderosa e alla ricerca di qualcosa. Forse il sogno non deve nascere come un progetto grandioso — forse può iniziare come una scintilla, non ancora utile, solo autentica.
E rispetto alla domanda "Dovrò convivere per sempre con questa apatia?", forse una riflessione possibile è: l’apatia è la mia identità o è uno stato che racconta quanto sono stata stanca, ferita, compressa? Buona ricerca. Per ulteriori chiarimenti non esiti a contattarmi, le auguro una buona giornata.

Gentile Francesca,
da quello che racconta emerge una grande sofferenza, ma anche una forte lucidità, sensibilità e capacità di pensiero. Non sta “buttando la sua vita”: sta cercando da molti anni di dare un senso a un sentire interno che non trova spazio né nel lavoro né nelle relazioni così come oggi le vengono proposte.
L’apatia che descrive non è pigrizia né mancanza di volontà. Spesso è il segnale di una depressione profonda e cronica, talvolta intrecciata a una fatica identitaria: sapere chi si è, cosa si rifiuta, ma non riuscire ancora a trovare una forma possibile e sostenibile per stare nel mondo senza tradirsi. In questi casi la rabbia (che lei sente) è spesso l’unica emozione “viva” rimasta, e paradossalmente può essere una risorsa da cui ripartire, se compresa e mentalizzata.
Il fatto che la lettura e lo studio libero (come l’arabo) la tengano in vita non è un dettaglio: indica che la sua mente funziona, si accende, si nutre, ma si spegne quando entra in contesti percepiti come vuoti, incoerenti o violenti sul piano dei valori. Questo non significa che lei sia “inadatta” al lavoro o alle relazioni, ma che probabilmente sta cercando risposte solo sul piano della motivazione, mentre il nodo potrebbe stare più a monte: nel rapporto con il desiderio, con l’autostima, con la possibilità di tollerare frustrazione e compromesso senza sentirsi annientata.
Dopo tanti anni di terapia e farmaci, può essere utile fermarsi e rimettere a fuoco il quadro diagnostico e il progetto terapeutico: capire che tipo di depressione è in gioco, se ci sono tratti di funzionamento (ad esempio sul piano emotivo o relazionale) che mantengono l’apatia, e come lavorarci in modo più mirato e profondo. Anche il lavoro farmacologico, sebbene già ampio, va sempre letto in integrazione con il percorso psicoterapeutico.
Capisco quanto sia faticoso sentirsi senza sogni, ma a volte il primo passo non è “trovare un sogno”, bensì tornare a sentire qualcosa di stabile dentro di sé, anche solo un minimo di vitalità e continuità emotiva. Questo è un lavoro che difficilmente si può fare da soli.
Le consiglierei quindi di approfondire la sua situazione con uno specialista, rivedendo insieme in modo strutturato storia, sintomi e obiettivi, per costruire un percorso più adatto a lei. Non è troppo tardi, e il fatto che lei continui a cercare aiuto è già un segnale importante.
Un caro saluto
Dottoressa Silvia Parisi
Psicologa, Psicoterapeuta, Sessuologa
da quello che racconta emerge una grande sofferenza, ma anche una forte lucidità, sensibilità e capacità di pensiero. Non sta “buttando la sua vita”: sta cercando da molti anni di dare un senso a un sentire interno che non trova spazio né nel lavoro né nelle relazioni così come oggi le vengono proposte.
L’apatia che descrive non è pigrizia né mancanza di volontà. Spesso è il segnale di una depressione profonda e cronica, talvolta intrecciata a una fatica identitaria: sapere chi si è, cosa si rifiuta, ma non riuscire ancora a trovare una forma possibile e sostenibile per stare nel mondo senza tradirsi. In questi casi la rabbia (che lei sente) è spesso l’unica emozione “viva” rimasta, e paradossalmente può essere una risorsa da cui ripartire, se compresa e mentalizzata.
Il fatto che la lettura e lo studio libero (come l’arabo) la tengano in vita non è un dettaglio: indica che la sua mente funziona, si accende, si nutre, ma si spegne quando entra in contesti percepiti come vuoti, incoerenti o violenti sul piano dei valori. Questo non significa che lei sia “inadatta” al lavoro o alle relazioni, ma che probabilmente sta cercando risposte solo sul piano della motivazione, mentre il nodo potrebbe stare più a monte: nel rapporto con il desiderio, con l’autostima, con la possibilità di tollerare frustrazione e compromesso senza sentirsi annientata.
Dopo tanti anni di terapia e farmaci, può essere utile fermarsi e rimettere a fuoco il quadro diagnostico e il progetto terapeutico: capire che tipo di depressione è in gioco, se ci sono tratti di funzionamento (ad esempio sul piano emotivo o relazionale) che mantengono l’apatia, e come lavorarci in modo più mirato e profondo. Anche il lavoro farmacologico, sebbene già ampio, va sempre letto in integrazione con il percorso psicoterapeutico.
Capisco quanto sia faticoso sentirsi senza sogni, ma a volte il primo passo non è “trovare un sogno”, bensì tornare a sentire qualcosa di stabile dentro di sé, anche solo un minimo di vitalità e continuità emotiva. Questo è un lavoro che difficilmente si può fare da soli.
Le consiglierei quindi di approfondire la sua situazione con uno specialista, rivedendo insieme in modo strutturato storia, sintomi e obiettivi, per costruire un percorso più adatto a lei. Non è troppo tardi, e il fatto che lei continui a cercare aiuto è già un segnale importante.
Un caro saluto
Dottoressa Silvia Parisi
Psicologa, Psicoterapeuta, Sessuologa

Buonasera, l'apatia potrebbe derivare da continui rinforzi negativi, queste esperienze se perdurano possono procurare depressione. Non so quale tipo di psicoterapia ha seguito ma riterrei utile una terapia cognitivo comportamentale per connettere le emozioni represse con connessi i suoi pensieri. Probabilmente sarebbe opportuno anche lavorare su eventuali traumi con l'ipnosi o EMDR. Inoltre sarebbe anche importante per lei praticare mindfulness, meditazione, rilassamento progressivo e respirazione diaframmatica, tutte metodologie proprie della CBT di terza generazione.
Quindi rendere funzionale ciò che allo stato attuale è disfunzionale e le impedisce di vedere la vita da altri punti di vista.
Buon proseguimento
Quindi rendere funzionale ciò che allo stato attuale è disfunzionale e le impedisce di vedere la vita da altri punti di vista.
Buon proseguimento

Buongiorno Francesca, ti ho sentito molto vicina. Da quanto scrivi sembra che tu abbia le idee chiare, ma sembra esserci allo stesso tempo qualcosa che ti blocchi, che si esprime attraverso l'apatia, la "difficoltà" a tenere un lavoro e ad isolarti. La rabbia che provi potrebbe essere un grande motore e catalizzatore, se solo riuscissi ad entrarci veramente in contatto,per poterne trarre vantaggio e beneficio. La rabbia è fuoco e passione, ed lì che dovresti andare a scavare. Hai un QI al di sopra della media, e si sa, le persone più intelligenti, soffrono di più e sentono di più. Mi auguro che con questo nuovo percorso di psicoterapia riesca a trovare lo slancio vitale e la fiducia in te stessa, nelle tue qualità e ad esprimere tutta la creatività che sembra stare lì nel fondo, che attende di essere sognata. A proposito di sogni, prova ad analizzare quelli che fai di notte, magari con l'aiuto del tuo terapeuta, lì ci sono chiavi per tante piccole grandi porticine che possono condurti al tuo Sè autentico. Sono sicura che possiedi un grande tesoro dentro di te che attende solo di essere visto, riconosciuto e validato, in primis da te.
Sono qui, se hai ancora voglia di un confronto.
Sono qui, se hai ancora voglia di un confronto.
Buongiorno Francesca,
dal Suo racconto emerge una sofferenza profonda e persistente, fatta di apatia, perdita di motivazione e senso di smarrimento, nonostante un lungo percorso di cure e tentativi. Non si tratta di mancanza di volontà, ma di una condizione complessa in cui identità, valori personali e funzionamento emotivo sembrano non trovare spazio nella realtà che La circonda.
L’apatia che descrive può diventare il centro del problema quando si cronicizza e spesso richiede un lavoro mirato, diverso dal “fare forza” o dal cercare un sogno a tutti i costi. Anche il conflitto tra i Suoi ideali e il mondo del lavoro è un nodo importante da esplorare, così come la solitudine e la rabbia che sente.
La invito a non affrontare tutto questo da sola: un colloquio conoscitivo potrebbe aiutarLa a fare ordine, ridefinire le priorità e valutare un percorso più aderente alla Sua storia e al momento che sta vivendo.
dal Suo racconto emerge una sofferenza profonda e persistente, fatta di apatia, perdita di motivazione e senso di smarrimento, nonostante un lungo percorso di cure e tentativi. Non si tratta di mancanza di volontà, ma di una condizione complessa in cui identità, valori personali e funzionamento emotivo sembrano non trovare spazio nella realtà che La circonda.
L’apatia che descrive può diventare il centro del problema quando si cronicizza e spesso richiede un lavoro mirato, diverso dal “fare forza” o dal cercare un sogno a tutti i costi. Anche il conflitto tra i Suoi ideali e il mondo del lavoro è un nodo importante da esplorare, così come la solitudine e la rabbia che sente.
La invito a non affrontare tutto questo da sola: un colloquio conoscitivo potrebbe aiutarLa a fare ordine, ridefinire le priorità e valutare un percorso più aderente alla Sua storia e al momento che sta vivendo.
Buongiorno Francesca,
dal suo racconto emerge una persona molto sensibile, idealista, attenta ai valori e poco disposta ad adattarsi a contesti che sente incoerenti o ingiusti. Spesso chi ha questa struttura emotiva forte e critica non soffre perché “non ha voglia”, ma perché per anni ha cercato di vivere in sistemi (scuola, lavoro, società) che non rispecchiano ciò che sente autentico.
In una lettura sistemica, l’apatia non è sempre assenza di desiderio: a volte è una forma di protezione dopo tante delusioni, tentativi falliti, scontri con ambienti percepiti come soffocanti. È come se una parte di lei si fosse spenta per non soffrire più.
Il fatto che l’unica cosa che ancora la nutre siano i libri e ora lo studio dell’arabo è molto importante: indica che la sua vitalità non è scomparsa, ma si accende quando c’è libertà, senso, scelta personale.
Il problema probabilmente non è “attivarla a forza”, ma capire che tipo di vita e di contesti possono davvero starle bene. Non tutte le persone stanno bene nei lavori standardizzati, competitivi o orientati solo alla produttività. Alcune hanno bisogno di spazi più creativi, culturali, autonomi, con valori in cui credere.
Dopo tanti anni di sofferenza, è normale sentirsi stanca e persa. Ma questo non significa che dovrà convivere per sempre con l’apatia: spesso è il segnale che la persona sta vivendo troppo lontano da ciò che è.
Continuare il lavoro terapeutico su identità, desideri e confini con il “sistema” che la circonda può essere molto più trasformativo che cercare solo di eliminare il sintomo.
Lei non è sbagliata: probabilmente è diversa in un mondo che fatica a fare spazio alle differenze.
dal suo racconto emerge una persona molto sensibile, idealista, attenta ai valori e poco disposta ad adattarsi a contesti che sente incoerenti o ingiusti. Spesso chi ha questa struttura emotiva forte e critica non soffre perché “non ha voglia”, ma perché per anni ha cercato di vivere in sistemi (scuola, lavoro, società) che non rispecchiano ciò che sente autentico.
In una lettura sistemica, l’apatia non è sempre assenza di desiderio: a volte è una forma di protezione dopo tante delusioni, tentativi falliti, scontri con ambienti percepiti come soffocanti. È come se una parte di lei si fosse spenta per non soffrire più.
Il fatto che l’unica cosa che ancora la nutre siano i libri e ora lo studio dell’arabo è molto importante: indica che la sua vitalità non è scomparsa, ma si accende quando c’è libertà, senso, scelta personale.
Il problema probabilmente non è “attivarla a forza”, ma capire che tipo di vita e di contesti possono davvero starle bene. Non tutte le persone stanno bene nei lavori standardizzati, competitivi o orientati solo alla produttività. Alcune hanno bisogno di spazi più creativi, culturali, autonomi, con valori in cui credere.
Dopo tanti anni di sofferenza, è normale sentirsi stanca e persa. Ma questo non significa che dovrà convivere per sempre con l’apatia: spesso è il segnale che la persona sta vivendo troppo lontano da ciò che è.
Continuare il lavoro terapeutico su identità, desideri e confini con il “sistema” che la circonda può essere molto più trasformativo che cercare solo di eliminare il sintomo.
Lei non è sbagliata: probabilmente è diversa in un mondo che fatica a fare spazio alle differenze.

Buonasera Francesca,
la prima cosa che desidero dirle è che dal suo messaggio emerge una grande sofferenza, ma anche una notevole lucidità e capacità di riflessione su di sé. Il fatto che lei riesca a raccontarsi con tanta profondità, nonostante si senta “spenta” e priva di slancio, è già un segnale importante: qualcosa dentro di lei continua a cercare senso, coerenza e verità.
L’apatia che descrive non appare come semplice “mancanza di voglia”, ma come un vissuto complesso e stratificato, che sembra intrecciarsi da anni con la fatica di trovare un posto nel mondo senza tradire i propri valori, la propria sensibilità e il proprio modo di sentire. In molte persone molto intelligenti, creative e non conformi, l’apatia può rappresentare non un’assenza di desiderio, ma una sorta di congelamento emotivo dopo ripetute esperienze di frustrazione, fallimento percepito o di adattamento forzato a contesti vissuti come violenti o alienanti.
Lei descrive una tensione costante tra il bisogno di lavorare e sopravvivere e il rifiuto profondo di identificarsi in ruoli che sente inautentici; tra il desiderio di legami e la difficoltà a trovarli; tra una mente molto attiva e un cuore che oggi fatica a sentire. In questo senso, l’apatia potrebbe essere anche una forma di difesa, una protezione dall’ennesima delusione, più che un “difetto” da combattere.
È significativo che i libri, lo studio autodiretto, l’apprendimento dell’arabo “per passione” siano ancora vivi: non sono dettagli marginali, ma indizi preziosi di ciò che in lei funziona, anche ora. A volte il problema non è “non avere un sogno”, ma averne avuti di profondi e non aver trovato un contenitore realistico e umano in cui potessero crescere senza schiacciarla.
Dopo molti anni di psicoterapia e di trattamenti farmacologici, può essere comprensibile sentirsi scoraggiata e pensare che “sarà sempre così”. Tuttavia, più che chiedersi come eliminare l’apatia, potrebbe essere utile – nel suo percorso terapeutico – interrogarsi su che cosa l’apatia sta raccontando di lei, della sua storia, delle sue rinunce forzate, della rabbia che sente (e che infatti è una delle poche emozioni ancora vive). Spesso la rabbia è un’emozione di confine: segnala che qualcosa di vitale chiede spazio.
Non esiste una risposta semplice o una soluzione rapida. Il lavoro psicoterapeutico, soprattutto in casi come il suo, non è tanto “attivare” a tutti i costi, quanto aiutare la persona a ricostruire un senso di continuità interna, di legittimità del proprio modo di essere, e solo successivamente trovare modalità di vita e di lavoro meno violente per il proprio funzionamento emotivo.
Il fatto che lei continui a chiedere aiuto, a curarsi, a porsi domande, nonostante la stanchezza e i pensieri di resa che emergono, indica che una parte di lei non ha rinunciato. Questo merita rispetto, non giudizio. Se in alcuni momenti il peso dovesse diventare insostenibile, è importante non restare sola e parlarne apertamente con il suo terapeuta o rivolgersi a un servizio di supporto immediato.
La domanda “dovrò convivere per sempre con questa apatia?” oggi non ha una risposta definitiva. Quello che si può dire è che l’apatia non la definisce tutta, e che il lavoro terapeutico può ancora diventare uno spazio in cui non “aggiustarla”, ma comprenderla profondamente, affinché qualcosa possa lentamente rimettersi in movimento, a modo suo e nei suoi tempi.
La ringrazio per aver condiviso la sua esperienza con tanta onestà. Non è persa: è ferma in un punto difficile del percorso, e questo non coincide con la fine della strada.
Un saluto.
Fabio
la prima cosa che desidero dirle è che dal suo messaggio emerge una grande sofferenza, ma anche una notevole lucidità e capacità di riflessione su di sé. Il fatto che lei riesca a raccontarsi con tanta profondità, nonostante si senta “spenta” e priva di slancio, è già un segnale importante: qualcosa dentro di lei continua a cercare senso, coerenza e verità.
L’apatia che descrive non appare come semplice “mancanza di voglia”, ma come un vissuto complesso e stratificato, che sembra intrecciarsi da anni con la fatica di trovare un posto nel mondo senza tradire i propri valori, la propria sensibilità e il proprio modo di sentire. In molte persone molto intelligenti, creative e non conformi, l’apatia può rappresentare non un’assenza di desiderio, ma una sorta di congelamento emotivo dopo ripetute esperienze di frustrazione, fallimento percepito o di adattamento forzato a contesti vissuti come violenti o alienanti.
Lei descrive una tensione costante tra il bisogno di lavorare e sopravvivere e il rifiuto profondo di identificarsi in ruoli che sente inautentici; tra il desiderio di legami e la difficoltà a trovarli; tra una mente molto attiva e un cuore che oggi fatica a sentire. In questo senso, l’apatia potrebbe essere anche una forma di difesa, una protezione dall’ennesima delusione, più che un “difetto” da combattere.
È significativo che i libri, lo studio autodiretto, l’apprendimento dell’arabo “per passione” siano ancora vivi: non sono dettagli marginali, ma indizi preziosi di ciò che in lei funziona, anche ora. A volte il problema non è “non avere un sogno”, ma averne avuti di profondi e non aver trovato un contenitore realistico e umano in cui potessero crescere senza schiacciarla.
Dopo molti anni di psicoterapia e di trattamenti farmacologici, può essere comprensibile sentirsi scoraggiata e pensare che “sarà sempre così”. Tuttavia, più che chiedersi come eliminare l’apatia, potrebbe essere utile – nel suo percorso terapeutico – interrogarsi su che cosa l’apatia sta raccontando di lei, della sua storia, delle sue rinunce forzate, della rabbia che sente (e che infatti è una delle poche emozioni ancora vive). Spesso la rabbia è un’emozione di confine: segnala che qualcosa di vitale chiede spazio.
Non esiste una risposta semplice o una soluzione rapida. Il lavoro psicoterapeutico, soprattutto in casi come il suo, non è tanto “attivare” a tutti i costi, quanto aiutare la persona a ricostruire un senso di continuità interna, di legittimità del proprio modo di essere, e solo successivamente trovare modalità di vita e di lavoro meno violente per il proprio funzionamento emotivo.
Il fatto che lei continui a chiedere aiuto, a curarsi, a porsi domande, nonostante la stanchezza e i pensieri di resa che emergono, indica che una parte di lei non ha rinunciato. Questo merita rispetto, non giudizio. Se in alcuni momenti il peso dovesse diventare insostenibile, è importante non restare sola e parlarne apertamente con il suo terapeuta o rivolgersi a un servizio di supporto immediato.
La domanda “dovrò convivere per sempre con questa apatia?” oggi non ha una risposta definitiva. Quello che si può dire è che l’apatia non la definisce tutta, e che il lavoro terapeutico può ancora diventare uno spazio in cui non “aggiustarla”, ma comprenderla profondamente, affinché qualcosa possa lentamente rimettersi in movimento, a modo suo e nei suoi tempi.
La ringrazio per aver condiviso la sua esperienza con tanta onestà. Non è persa: è ferma in un punto difficile del percorso, e questo non coincide con la fine della strada.
Un saluto.
Fabio

Buonasera comprendo il Suo malessere ma purtroppo non possiamo cambiare il mondo che ci circonda se non impariamo chi siamo e perchè a volte ci sentiamo apatici e depressi. La lettura sembra una via di fuga dalla realtà, ma occorre affrontare realmente la propria rabbia e capire da dove scaturisce. la psicoterapia La può aiutare certamente e credo sia utile che Lei ricostruisca la Sua storia di vita che forse ancora richiede del tempo per essere compresa fino in fondo. Cordiali saluti dott.ssa G.Elmo
Buongiorno,
lei è già in cura con uno psichiatra ed ha pure intrapreso un percorso di psicoterapia. Porti i temi qui espressi in terapia, sono un importante spunto di riflessione su cui soffermarsi e da cui ripartire.
Cordiali saluti
Dott. Diego Ferrara
lei è già in cura con uno psichiatra ed ha pure intrapreso un percorso di psicoterapia. Porti i temi qui espressi in terapia, sono un importante spunto di riflessione su cui soffermarsi e da cui ripartire.
Cordiali saluti
Dott. Diego Ferrara

Salve. Mi dispiace per questa situazione di stallo che sta vivendo e credo di comprendere il senso di questa apatia che descrive. Facendo da molti anni psicoterapia avrà sentito parlare molto del setting della terapia; io credo che in questo ci sia un elemento importantissimo che può veramente aiutarla. Per setting si intende l'inquadramento generale delle sedute, la frequenza delle sedute, l'integrazione fra il contributo di specialisti diversi (psichiatra, psicoterapeuta, educatore ecc.). Perciò se si prendono farmaci sarà importante che lo psichiatra che li prescrive abbia un confronto diretto e approfondito con lo psicoterapeuta. Spero che nel suo caso sia seguita così, altrimenti le consiglierei di cercare un nuovo assetto. La psicoterapia può offrire un opportunità trasformativa, ma nel contempo Lei dovrà valorizzare con fermezza i traguardi raggiunti senza criticarsi, e senza sminuirsi. Così anche le relazioni possono essere vissute con pienezza se si valorizzano le persone e si smette di idealizzarle per poi rimanerne delusi. Dobbiamo venire a patti con i nostri valori e dare innanzitutto valore alla nostra Persona. Le dirò una cosa che magari può sembrare fuori contesto; siccome mi occupo di pittura e disegno espressivo, dico sempre ai miei allievi che per disegnare e dipingere è necessario sopravvivere alla frustrazione dei propri errori e della propria incapacità. Se disegnando non riesco a trasformare l'errore in creatività smetterò presto. Se ho in mente la precisione e l'infallibilità smetterò presto. Se sarò come un bambino che disegna vedrò un veliero dietro una linea a mezzaluna, mentre un trattino dritto e po' ricurvo saranno l'esatta espressione di un uomo pensante e malinconico. Le scrivo questo perché credo che anche nella vita, dobbiamo creare valore a partire dalle nostre capacità e possibilità. Non vuol dire accontentarsi ma saper godere del percorso e progettare i giusti viaggi
Cordialmente
Dr Vecchi
Cordialmente
Dr Vecchi
Stai ancora cercando una risposta? Poni un'altra domanda
Tutti i contenuti pubblicati su MioDottore.it, specialmente domande e risposte, sono di carattere informativo e in nessun caso devono essere considerati un sostituto di una visita specialistica.